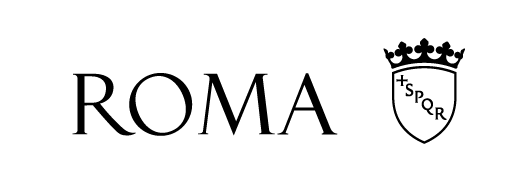domenica
4
luglio
Patria
22 aprile - 4 luglio 2021
Le recensioni di Anna Violati, coordinatrice del Circolo di Lettura
Il romanzo Patria di Fernando Aramburu (Premio Strega europeo 1918) segna il ritorno alla grande tradizione del romanzo occidentale. E’ un romanzo corale, storico, di formazione, di analisi che si rifà anche alla lezione del Realismo e del Modernismo. Al centro dell’opera, in un arco temporale dal 1970 ai giorni nostri, in un paesino basco della provincia di San Sebastian, è la storia di due famiglie inizialmente legate da una profonda amicizia, a cui un evento luttuoso porrà fine, trasformandole in nemiche su opposti fronti. La famiglia di Taxto e Bittori, con i loro figli, Nerea e Xabier, grazie alla solida impresa di trasporti del capofamiglia vive una vita agiata. Miren con i tre figli, Joxie Mari, Arantaxa e Gorka, deve contare sul solo stipendio da operaio di fonderia del marito Joxian e sui prodotti dell’orto che l’uomo coltiva, che è per lui anche una sorta di rifugio. Nonostante le differenze economiche, Taxto e Joxian, uomini schivi, condividono il tempo libero tra giri di biciclette sulle colline e serate all’osteria, mentre Bittori e Miren si concedono dolci colazioni nella pasticceria del paese. I rispettivi figli giocano insieme crescendo anche in amicizia. Ma a dividere le due famiglie e a rompere i loro rapporti e insieme lacerare la comunità del paese è l’assassinio di Taxto da parte dell’ETA, l’organizzazione terroristica basca nazionalista e separatista, nelle cui file milita Joxie Mari, il primogenito di Joxian. L’idea di patria per lui si incarna nella lotta indipendentista della terra basca, anche con il ricorso alla violenza, per cui il fine giustifica i mezzi. La molla narrativa che fa scattare l’avvio del romanzo è il recente abbandono della lotta armata nel 2011 da parte dei terroristi baschi, ma Patria ruota intorno all’uccisione di Taxto, rifiutatosi di pagare “la tassa rivoluzionaria” di finanziamento all’ETA e al sospetto che Joxie Mari ne sia stato il responsabile, nonché alla sua lunga latitanza fino all’incarcerazione. L’omicidio getta una profonda frattura non solo nelle famiglie, ma anche nella comunità del paese seminando odio, isolamento, rancore, paura. Come se tale avvenimento avesse ”cristallizzato” tutti, bloccandoli in un eterno presente dal quale è impossibile liberarsi. Si può dire che ogni altro evento è narrato, ricordato e accaduto a una determinata distanza dall’assassinio, come pensa Xabier, “si è laureato in medicina sette mesi prima, ha partecipato ad un congresso nove anni dopo”. Nerea ricorda che ha visto il padre, per l’ultima volta un anno prima della sua morte, quando era a Saragozza per gli studi universitari. Anche gli altri personaggi, attraverso i loro ricordi, riflettono le ripercussioni di quel tragico evento, che ha cambiato la vita di tutti. Le difficoltà di elaborare i lutti, compresa l’incarcerazione di Joxe Mari, impedisce di riconciliarsi con il passato e tutti si sentono vittime, compresa Miren che dirà: ”siamo vittime dello stato e vittime delle vittime”. Tutto è rinchiuso in un circolo vizioso in cui le emozioni, i sentimenti, i sogni, le speranze sono condannati a implodere e a non trovare via d’uscita. E’ un romanzo che fa dell’universo-famiglia il fulcro morale, il centro vitale della trama, in cui campeggiano le figure femminili: Bittori e Miren sono donne forti, determinate e racchiuse nella loro condizione familiare e sociale. Bittori ripiegata nel suo lutto, che non arretra dalla ricerca della verità sulla morte del marito e dalla richiesta di perdono da parte del presunto responsabile. Miren tenace sostenitrice del figlio, affiliato all’ETA, diventa lei stessa una convinta abertzale, una esaltata “patriota” per la forza del suo legame materno, schiacciando amicizie e affetti di una vita. Nerea, figlia di Bittori, ed Arantxa, figlia di Miren, portano dentro una sofferenza che le segna per la vita. Nerea rifiuta il ruolo di vittima, ma senza riuscirci, non tornerà al paese per partecipare al funerale del padre, non rivelerà il modo in cui è morto il padre al futuro marito, con cui non condividerà il domicilio. Arantxa, consapevole e positiva, riuscirà ad abbattere il muro di odio e di rancore. Pur racchiusa nella prigione di un corpo reso invalido da un ictus e priva di parola, con l’uso di un I-Pad tesse una tela che porterà le due famiglie a riallacciare in qualche modo i rapporti. Gli uomini, Xavier, Joxie Mari e Gorka, sono comprimari. Mentre la storia ruota intorno alla militanza e alla detenzione di Joxie, Xabier è ripiegato in un autodistruttivo dolore, ritiene indegno cercare di strappare alla vita pezzi di felicità dopo la morte del padre, provando una specie di repulsione nei confronti dell’allegria. L’altro, che riflette in qualche modo l’autore, si salva dalla pressione del fratello e del gruppo terroristico attraverso la scrittura e la letteratura. Mentre i capifamiglia sono persone schive, di poche parole, succubi delle mogli ma legati alle famiglie, i coniugi delle figlie sono superficiali, egoisti e poco affidabili. In questa comunità emergono forti valori, soprattutto il bene della famiglia e l’unità di questa deve prevalere su tutto. E’ predominante la presenza della chiesa con i suoi miti e riti. Con la morte del marito Bittori perde la fede, ma di tanto in tanto va a messa spinta dalla forza dell’abitudine. “Preferisce sedersi in chiesa e praticare il suo ateismo silenzioso”. Miren va a messa regolarmente e siede davanti alla statua di S. Ignazio per parlare con lui, come se fosse un altro suo figlio, chiedendogli di rimettere in piedi la figlia e di tirare fuori dal carcere il figlio, minacciandolo altrimenti di non rivolgergli più la parola. La donna ha un sostenitore nel parroco Don Serapio che ha scelto di aderire alla lotta armata, convinto che ricada su di lui “la missione cristiana di difendere la nostra identità, la nostra cultura e la nostra lingua”. Rassicura Miren sulla necessità della lotta e di portare al figlio “la sua benedizione”. Nella prigionia, in cui subisce torture, a poco a poco Joxie comprende che la sua vita poteva avere un percorso diverso, si fa strada in lui la verità: ”aveva fatto del male, aveva ucciso per niente, né socialismo, né indipendenza, in nome di principi che altri avevano creato e che lui obbediente, ingenuo aveva assimilato”. La canzone "Txoria Txori" del passero (parole del poeta Artze e musica di Laboa), che accompagna la solitudine di Joxie Mari nei suoi lunghi anni di carcere, fa parte del patrimonio tradizionale basco, che ha accompagnato il sogno di indipendenza del popolo basco alla ricerca della libertà, che è indicato nell’acronimo ETA: EUSKADI TA ASKATASUNA (PAESE BASCO E LIBERTA’). La fotografia di Arantxa sulla sedia a rotelle e la sua lettera di esaudire la richiesta di Bittori sono il colpo d’ascia definitiva che “abbatte l’albero maestro della nave”. Merito dello stile narrativo se il lettore sente di immergersi in un mondo possibile, verosimile grazie all’andirivieni temporale nelle vicende, al costante ricorso al discorso indiretto libero, all’alternanza tra la prima e la terza persona che consente di entrare ed uscire dalla testa dei personaggi. I numerosi flashback mirano a far conoscere, ripercorrere, ricostruire le vite di molti personaggi, da prospettive umane differenti. Per la preoccupazione di definire in maniera psicologicamente precisa una sensazione, l’autore ricorre all’uso prima di un aggettivo, subito dopo in forma dubitativa con il punto interrogativo di un secondo aggettivo, oppure accostando due aggettivi divisi tra loro da una barra obliqua (“le era difficile/impossibile?“, "un dolore sordo/vago”). L’uso dell’ellissi nei discorsi indiretti, una prosa molto parlata ed emotiva fa intuire una profonda consapevolezza da parte dell’autore dei propri mezzi espressivi, che rendono intensa e scorrevole la lettura. Gli errori nell’uso dei congiuntivi abbondano, e non è un caso, nei personaggi meno colti che praticano la violenza e la rivendicano o la giustificano. Disseminate in tutto il romanzo le parole in lingua basca, soprattutto dove sono presenti i personaggi abertzales, patrioti sostenitori dell’indipendenza basca. Il climax drammatico è stemperato di frequente da momenti più leggeri di ironia, soprattutto nelle rappresentazioni della vita domestica. Bittori che parla con le stoviglie e la fotografia del marito, i battibecchi in entrambe le coppie, Miren che redarguisce S. Ignazio, determinano quell’alternanza tra tragedia e commedia che caratterizzano i grandi capolavori letterari. Patria è un romanzo che condanna le azioni violente dei terroristi nutriti di un idealismo insensato ma denuncia anche i soprusi della polizia che ha incarcerato e torturato i terroristi. Racconta anche con coraggio il ruolo del clero nell’alimentare l’indottrinamento per il mito: EUSKADI TA AZKATASUNA. Un ruolo rilevantissimo assume per lo scrittore quell’impegno etico dell’intellettuale nella società, che lo vede partecipe della società civile. Aramburu anche attraverso la figura di Gorka insiste sul ruolo dei libri e della cultura come antidoto alla violenza e agli estremismi, che aiuta a prendere consapevolezza dei problemi e a discuterne. L’ignoranza, la mancanza di cultura sono il terreno fertile per far germogliare il seme dell’avversione e della ferocia. Il romanzo non ha natura politica, vuole essere soprattutto la celebrazione del pentimento e del perdono, sentimenti più difficili da provare ed esternare. A tale proposito la lettera di richiesta di perdono a Bittori da parte di Joxie Mari è un piccolo capolavoro, nella sua laconicità ha una grande forza espressiva ed emotiva. In una intervista Aramburu sostiene che il suo libro non è un romanzo a tesi sulla società basca né tantomeno sul terrorismo. Gli interessano la gente, gli individui, i legami. Non voleva che i personaggi incarnassero delle astrazioni, che fossero dei recipienti di idee o concetti. “A tutti volevo conferire spessore umano, complessità, sfumature, anche a quelli che nella vita mi sarebbero stati più distanti”.
Fernando Aramburu, Patria, Guanda, 2017
.