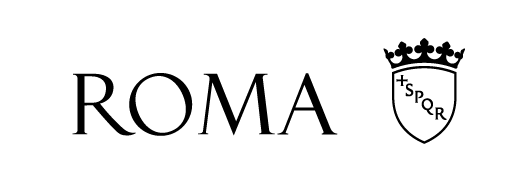mercoledì
27
gennaio
lunedì
18
gennaio
mercoledì
27
gennaio
Dante
18 - 27 gennaio 2021
Le recensioni di Anna Violati, coordinatrice del Circolo di Lettura
Lo storico
Alessandro Barbero, con grande abilità narrativa e rigoroso impegno metodologico, guida il lettore in modo graduale alla conoscenza delle vicende personali di
Dante Alighieri, nel contesto sociale e culturale del Trecento, attraverso l’analisi di documenti notarili, dei versi delle sue opere letterarie e di testimonianze di vari autori. Tutto ciò consente al lettore di conoscere Dante, grande poeta rivoluzionario nel campo letterario, ma profondamente immerso nel suo tempo, con le sue passioni, fragilità e contraddizioni. In apertura del libro Barbero ci mostra un inedito Dante nell’insolita veste per il lettore di giovane armato a cavallo, tra i “feditori” nella battaglia di Campaldino (11 giugno 1289) contro gli Aretini - ciò per rispondere alla domanda se il nostro poeta fosse nobile. Nella Firenze di allora chiunque appartenesse ad una famiglia ricca e fosse disposto a spendere per un “addobbamento”, con il suo rituale per legge, diventava cavaliere e si poteva fregiare del titolo di “messere” (nobile, gentile). Ma Dante non era stato armato cavaliere quel mattino. Giovane poeta, figlio del ricco cambiavalute Alighiero di Bellincione, sognava di entrare a far parte del mondo dei letterati e dei nobili, quello del suo trisavolo Cacciaguida. In seguito si glorierà della sua nobiltà di sangue che, ribadirà, deve essere accresciuta con nuove azioni virtuose. L’amicizia con Manetto Portinari, Forese Donati e, soprattutto, Guido Cavalcanti (fratello dell’anima) con cui scambiava versi in volgare, lo introdussero in un ambiente sociale molto più alto. La vena poetica di Dante e Guido trovò in Firenze, grande metropoli, città mercantile, l’habitat naturale per esprimersi e crescere: un ambiente libero, laico e spregiudicato. Ma la stagione poetica giovanile sembra chiudersi con la giovinezza stessa, con la composizione della “Vita Nova” (1292), dove percorre in chiave poetica le tappe del suo innamoramento per Beatrice, andata sposa ad un altro uomo e scomparsa prematuramente. Nel frattempo con le sue “Canzoni” e i suoi ”Versi” Dante ha raggiunto una discreta notorietà. Ma la sua altra grande passione era la politica, forte della formazione umanistica ricevuta dal maestro Brunetto Latini, che insieme all’“ars dictaminis”, all’insegnamento dello stile e della retorica lo rendeva padrone di tutti i mezzi espressivi, dalla poesia al discorso politico. Verso i trent'anni aveva cominciato a partecipare all’attività politica, probabilmente già prima del 1295, ma i documenti attestanti la sua attività politica si riferiscono a un arco temporale di 6 anni, dal 1295 al 1301. Il Comune di Firenze era dominato da un “regime di popolo”. Il Governo era costituito da sei
Priori delle Arti, espressione del mondo imprenditoriale e artigiano, dal
Gonfaloniere di giustizia, incaricato di far rispettare gli Ordinamenti di giustizia di Giano della Bella. Sotto di loro erano cinque
Consigli dove sedevano centinaia di cittadini oltre i
Collegi Consiliari che dirigevano le 21
Corporazioni. Quindi c’era una larga partecipazione del popolo agli incarichi di governo che non erano affidati a politici di professione ma venivano ricoperti a turno da un grandissimo numero di persone. Nel luglio del 1295 Firenze era sull’orlo della guerra civile: i “magnati” esclusi dal potere volevano che gli Ordinamenti fossero modificati e quindi erano scesi in piazza armati ma contro di loro era pronto alle armi il popolo dei mercanti. Nel
Consiglio dei Cento del 6 luglio si giunse ad un compromesso, fautore anche Dante, e si volle venire incontro a chi, pur appartenendo alle ”antiche famiglie dei Magnati”, fosse disposto ad iscriversi ad un’Arte. Dante, in base alle normative vigenti, iscritto alle Arti dei medici e degli speziali, politicamente era un
plebeius, un popolano di orientamento moderato, incline a un compromesso con i Nobili, inorridito “dalla dittatura della gente dappoco”, fautore della supremazia della legge in difesa della concordia e del bene comune, contrario alla violenza dei Magnati. Questi ultimi continuavano ad esercitare un’enorme influenza nella vita politica fiorentina per il peso del numero, della ricchezza, delle clientele, delle forze militari e del ricorso alla violenza. A conferma della sua collocazione personale Dante dal 1 novembre del 1295 al 30 aprile del 1296 venne nominato tra i 36 membri del
Consiglio speciale del Capitano del popolo, espressione dei ceti borghesi. Nella vita politica della città si stava aprendo un’altra frattura, i grandi Guelfi si erano divisi in Bianchi e Neri, capeggiati da due famiglie, i Cerchi e i Donati. Dante, seppur imparentato con i secondi, era più vicino ai Cerchi che cercavano di rafforzare la loro posizione con l’appoggio dei popolari al governo. Il Papa Bonifacio VIII cercava con l’aiuto del suo legato, il Cardinale Matteo di Acquasparta, apparentemente di mettere pace tra le fazioni, ma in realtà era deciso ad appoggiare quella dei Donati di cui facevano parte i suoi banchieri. Nel 1296 il nostro poeta era entrato nel
Consiglio dei Cento preposto alla delibera delle spese e, proprio in qualità di membro di quel Consiglio, si era attirato l’odio e il rancore di Bonifacio VIII per aver fatto bloccare tutti i finanziamenti straordinari da lui richiesti. Fu nel gruppo dei Savi che nel dicembre 1296 rinnovarono le norme per l’elezione dei Priori, i massimi rappresentanti di ciascuna Arte, che avrebbero ricoperto, per un bimestre, il ruolo istituzionale più importante della Repubblica. Dal maggio al dicembre del 1296 fece parte del
Consiglio dei Cento. Nel maggio del 1300 fu inviato come ambasciatore a San Gimignano per rafforzare la Lega guelfa tra i Comuni della Toscana. Nello stesso anno, cruciale per la città per le continue violenze dei Neri, Dante ricoprì la carica di Priore che rappresenterà al tempo stesso l’apice e la discesa della sua rapida carriera politica. Le decisioni prese furono drammatiche a tal punto che in una sua lettera scrisse che “tutti li mali e gli inconvenienti miei dalli infausti comizi del mio priorato ebbero cagione e principio”. Sono giorni che anni dopo descriverà come quelli in cui è andato vicino a perdere l’anima. Da giugno a settembre del 1301 si susseguirono vari Consigli in cui egli continuava ad essere un esponente di spicco del regime che stava colando a picco. Il 28 settembre partecipò al
Consiglio dei Cento con una lunga lista di provvedimenti, alcuni di ordinaria amministrazione, altri più importanti e inquietanti. Tutte le proposte passarono anche con il suo parere favorevole ma era l’ultima volta, lui inconsapevole, che si alzava a parlare in uno dei Consigli del Comune. I primi di novembre del 1301 Carlo di Valois, inviato dal Papa, entrò a Firenze con 1200 cavalieri, fece arrestare i capi dei Bianchi mentre Corso Donati e gli altri confinati rientravano in città. Per sei giorni circa i Neri uccisero, saccheggiarono, incendiarono e devastarono, tra le altre, anche le proprietà degli Alighieri. Fu costituita una nuova Signoria di “pessimi popolani” che cominciarono a montare false accuse e istruire processi politici contro gli avversari. Dante, di ritorno probabilmente da un’ambasceria a Roma, alla sede papale, fu accusato di concussione. Era già a Siena nella primavera-estate del 1302 e, per sfuggire alla condanna, si unì agli esuli ribelli, Bianchi e Ghibellini coalizzati con l’appoggio degli Ubertini, in occasione di un incontro a Gorgonza, divenendo uno degli esponenti più in vista della coalizione contro Firenze al grido: “Muoiano i Guelfi”. Dante non aveva smesso di essere guelfo e non era divenuto ghibellino. A tenere insieme gli schieramenti era la trasversalità dei partiti e la convenienza del momento, la condizione di esiliati piuttosto che la fede ideologica. Ma le operazioni militari volsero a sfavore dei fuoriusciti. Al cardinale Niccolò da Prato, inviato dal Papa Benedetto XI, scontento del governo dei Neri, il nostro poeta scriverà una lettera in nome dei Bianchi informandolo che i fuoriusciti erano pronti ad obbedire ai suoi ordini e ad accettare le sue condizioni di pace ribadendo che i Bianchi erano quelli che amavano veramente Firenze, rivendicando la responsabilità di aver combattuto una guerra civile in difesa della libertà, confidando nella sua opera di pace (“cos’altro chiedevano le nostre candide insegne e per cos’altro erano rosse le nostre spade”). Il fallimento della missione di pace non scoraggiò i fuoriusciti, rinacque in loro la speranza di poter riprendere la città con la forza. L’esito disastroso della
giornata della Lastra indusse Dante, uno dei Consiglieri dirigenti del partito, a lasciare la compagnia “malvagia e scempia”. La rottura con i Bianchi fu violentissima perché entrambi i partiti, Bianchi e Neri, erano assetati di sangue. Ormai sconfitta e dispersa l’Universitas Alborum, Verona fu il primo dei luoghi dove Dante andò come peregrino quasi mendicante. Confessa (
Convivio) di essere “legno sanza vela e sanza governo portato a diversi porti e a diverse foci e liti". In realtà quello che gli brucia di più è di essere visto in miseria da chi prima lo ammirava. Trovò ospitalità presso altri Signori, grazie al fatto di essere un politico nato, un poeta e un
dictator di chiara fama. Fu impiegato in qualche occasione nelle cancellerie dei Signori presso i quali risiedeva, scrivendo lettere a nome dei suoi ospiti. Ma non si fermò mai molto a lungo in nessun luogo. Secondo Boccaccio e altri autori trecenteschi, tra il 1306 e il 1310 Dante, tornato da Verona, visse parecchi anni ospite di diversi nobili dell’Appennino Centrale: i conti Guidi, i marchesi Malaspina, i signori Della Faggiola. Quindi andò in seguito per studio a Bologna, a Padova, a Parigi (dove disputando più volte mostrò l’altezza del suo ingegno). Tornò in Italia quando la discesa di Enrico VII (1310) risvegliò le sue speranze di un possibile rientro. Ma la morte improvvisa dell’imperatore lo gettò in uno stato d’animo particolare tanto da indurlo a chiedere perdono ai Neri, padroni di Firenze. Si dichiara equidistante dai due partiti contrapposti (
tre donne intorno al cor mi son venute), è pentito delle colpe per cui è tenuto lontano da Firenze, invita i Neri ad essere saggi e perdonarlo, perché hanno vinto e lui si arrende. Sono tempi difficili per Dante, un tempo cittadino e politico di spicco di un Comune, ora la sua vita al servizio dei nobili come cortigiano gli pesava, così come le difficoltà economiche. Spesso era costretto a lasciare questa o quella Corte perché provvedimenti restrittivi presi contro i fuoriusciti fiorentini potevano creare problemi ai suoi ospiti. Intanto scriveva non poesie d’amore ma le sue opere più importanti. Progettava di dare vita a un’opera che gli avrebbe dato onore e fama da far pentire i Fiorentini per non avergli concesso il rientro e per non essersi ribellati alla vergognosa campagna di diffamazione di cui era stato fatto oggetto. Quindi l’opera di Dante si indirizzò verso la filosofia che conduce alla vera sapienza. Il modello è Boezio sia come “amico” che come maestro di vita. Non c’è una sicura documentazione degli anni dopo il soggiorno a Verona dagli Scaligeri e ci sono anche vistose contraddizioni tra i giudizi da lui espressi in epoche diverse e in contesti diversi a proposito dei Signori a cui doveva riconoscenza (vedi i Guidi e gli Scaligeri). Forse l’encomio in alcune circostanze lo sentiva quasi un obbligo nei confronti di un Signore che lo ospitava provvedendolo di tutto ciò che gli necessitava. Escluso dall’amnistia del 1311 per le invettive lanciate contro Firenze e le lettere inviate a Enrico VII, gli era possibile rientrare a Firenze con l’amnistia del 1315 se avesse accettato, in cambio, di offrire una certa quantità di denaro. Ma “egli, che predicava la giustizia, non voleva pagare col proprio denaro coloro che quell’ingiustizia avevano commesso”. Doveva riconoscere la propria colpa, compiere una pubblica penitenza, fare a piedi una processione culminante nel Battistero di S .Giovanni, dove avrebbe indossato uno speciale cappello, il pileo. Tutto ciò sarebbe stato umiliante. Negli ultimi anni, dopo il soggiorno a Verona, accettò l’invito di Guido Novello Da Polenta, Signore di Ravenna e anche lui poeta e autore di Canzoni. In questa città intratteneva relazioni con medici, notai, uomini colti che condividevano interessi letterari e che, sopravvissuti a Dante, contribuiranno alla “rapida crescita della sua gloria”, facendo pubblicamente vanto della propria amicizia con lui. Proprio a Ravenna Dante riuscì a mettere a posto due dei suoi figli: Piero e Beatrice. Al primo vennero assegnati due redditizi benefici ecclesiastici, mentre la seconda divenne monaca nel Monastero di Santo Stefano degli Ulivi. Sempre a Ravenna terminò la
Commedia e anche, purtroppo, la sua vita, dopo essersi ammalato di malaria al ritorno da un’ambasceria per conto dei Polenta a Venezia.
Barbero ci ha così presentato e raccontato Dante Alighieri, ma le molte lacune della sua biografia rendono incerta la ricostruzione di fasi della sua esistenza e sollevano perplessità sui giudizi contraddittori espressi dal poeta in tempi diversi nei confronti degli ospiti. Quindi, nei casi controversi, lo scrittore propone le diverse ipotesi che nei secoli si sono prodotte, analizzandone i pro e i contro al fine di consentire al lettore l’onore e l’onere della sua interpretazione o risposta. Ma un indubbio grande merito dell’opera dello storico è quello di aver legato la vita di Dante alla vita degli uomini dell’Italia del ‘300, offrendo uno squarcio al lettore sulla vivacità e varietà sociale, culturale e politica dell’epoca. Fornisce così un quadro complessivo su quella che era la vita nel Medioevo nelle grandi metropoli come Firenze, città ricca di traffici finanziari (con i suoi centomila abitanti era la città più grande d’Europa), nei centri urbani vivacissimi e prosperi come Ravenna e Verona, nei centri culturali come Padova e Bologna: città universitaria la prima, massimo centro di studi aristotelici la seconda. Affiora così la storia e la cultura di un’epoca che è stata la culla della modernità.
Alessandro Barbero, Dante, Laterza, 2020
Le precedenti recensioni: