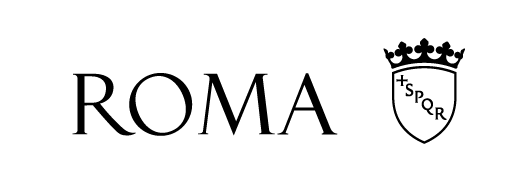mercoledì
6
gennaio
mercoledì
25
novembre
mercoledì
6
gennaio
La figlia ideale
25 novembre 2020 - 6 gennaio 2021
Le recensioni di Anna Violati, coordinatrice del Circolo di Lettura
Mario Vargas Llosa definisce Almudena Grandes una delle più grandi scrittrici contemporanee, a ragion veduta lo conferma questo romanzo, che è il quinto libro della serie al servizio della storia, con episodi di una guerra interminabile, quella civile, nella Spagna franchista, narrati attraverso la vita di diversi personaggi.
Intorno alla tragica reale storia di Aurora Rodriguez, rinchiusa nel manicomio femminile a Ciempezuelos nel 1933, avendo ucciso nel sonno la giovane figlia Hildegarth - leader influente del femminismo e della Lega per la Riforma sessuale -, la scrittrice costruisce un romanzo, possente e avvincente, insieme ad altri due personaggi: lo psichiatra Germàn Velasquez e la sua assistente Maria Costejon. Infatti sono le tre voci narranti in prima persona che si alternano nelle pagine, nella diversità dei punti di vista e dello stile narrativo. Attraverso l’analisi interiore individuale il lettore scopre i loro pensieri e le loro vicende in una Spagna oppressa dalla dittatura franchista. La storia, ambientata negli anni 1953-1956, ha inizio quando allo psichiatra Germàn esiliato in Svizzera da anni, avendo condotto una importante sperimentazione in una clinica di Berna sul nuovo farmaco della clorpromazina, gli viene proposto di tornare in Spagna per attuarla anche nel manicomio di Ciempezuelos. Aveva lasciato la Spagna giovanissimo per la Svizzera, nel 1939, con l’aiuto del padre per sfuggire alla persecuzione della dittatura e inizialmente ospitato dalla famiglia dell’ebreo tedesco Goldstein, anche lui esiliato, compiva gli studi di medicina e successivamente ne sposava una figlia e da lei divorziava. Coinvolto nelle dolorose vicende della famiglia ebraica, ci rivela un panorama storico più ampio e complesso, quello della Germania nazista, messo a confronto anche con la libera Svizzera e con la Spagna franchista. Nella complessità delle storie, caratterizzate da storie più brevi all’interno di altre più estese, è riconoscibile l’influsso dello scrittore Cervantes. La giovane ausiliaria Maria Castejon, nipote del giardiniere del nosocomio, dove lei è nata e ha passato gran parte della sua vita, affezionata a donna Aurora, che da piccola le aveva insegnato a leggere e a scrivere insieme a molte altre cose e con cui sa relazionarsi, cela dolorose esperienze di vita. Nella sua ingenuità, nella sua passione, nelle sue delusioni rispecchia Fortunata, la protagonista del libro da lei letto “Fortunata e Giacinta” di Benito Perez Galdos, altro autore modello ispiratore per la scrittrice. Rappresenta per Velasquez lo zabaione, ”le sue parole sapevano di zabaione”, che preparato dalla sua tata Ina, portava gusto e gioia nelle sue giornate infantili (come le Madelein di Proust). Tra i due nasce una relazione, che pur non avendo un lieto fine come coppia, porterà gioia e calore nella loro vita. Essi sono l’archetipo del sopravvissuto, tema prediletto dalla scrittrice - sotto l’influsso di Robinson Crusoe di Defoe e di Ulisse dell’Odissea omerica - cioè di coloro che desiderano fuggire dal loro passato e hanno il coraggio di volere cercare un’altra opportunità di vita, sfidando pregiudizi, la morale ottusa e il giogo della dittatura. Donna Aurora Rodriquez, di cui la scrittrice si fa magistralmente interprete, nel pensiero e nei suoi sproloqui, suscita sentimenti contrastanti: ammirazione per la sua cultura e intelligenza, per le sue capacità di pianista e di pedagoga; orrore per il suo delitto; compassione per le sue idee folli. Paladina dell’eugenetica, visti vani i suoi tentativi di dar vita a dei pupazzi, convinta di avere una missione: concepire il redentore dell’Umanità, con l’aiuto di Germàn, ci appare anche lei una vittima non tanto della paranoia, quanto delle conseguenze dell’ideologia. La vita del manicomio riflette non solo la gerarchia sociale, con diversità nei pasti, negli alloggi, fra le pazienti ricche e quelle povere, ma soprattutto l’atmosfera cupa di una morale asfissiante della vita quotidiana nella Spagna franchista, in cui tutto era peccato. La dittatura esercitata attraverso il terrore e la repressione soffocava ogni forma di mobilitazione. Parlare, scrivere, leggere libri e riviste proibite erano attività sospette che potevano attirare l’attenzione di chi aveva conoscenze in polizia. Il silenzio era l’unica arma sicura, l’unico rimedio efficace contro la rovina. “Qualunque cosa accada, per quello che ti sta a cuore, tu non farti notare!”, questo era il ritornello ripetuto in famiglia insieme alla raccomandazione di non parlare di quello che accadeva in casa. ”La Spagna era il feudo di un generale fascista ben issato sulla groppa della Chiesa cattolica”. Le vittime maggiori delle conseguenze dell’alleanza tra lo Stato e la Chiesa furono le donne, perché condizionò la loro vita privata, le imprigionò in una “gabbia”, limitò la loro libertà per impedire che fossero felici. Lavoravano come bestie con stipendi da fame, senza alcun diritto, non potevano prendere decisioni autonome, passando direttamente dalla tutela dei genitori a quella dei mariti, perdendo la loro libertà. Sotto l’influsso delle teorie eugenetiche di Vallejo Nàjera, psichiatra e direttore del manicomio, celebre autore della teoria che il marxismo era un gene perverso, associato all’inferiorità mentale, che andava estirpato a tutti i costi, venivano strappati i figli neonati alle madri, ritenute non idonee, con falsi certificati di morte e con la complicità di sacerdoti e suore per farli crescere in famiglie irreprensibili, che avrebbero saputo neutralizzare un pessimo patrimonio genetico, attraverso un’adeguata educazione religiosa e patriottica. Similmente accadrà al momento del parto, alla paziente Rafaela, vittima di uno stupro. L’atteggiamento empatico, la capacità di relazionarsi, il desiderio di migliorare le condizioni mentali delle pazienti, da parte degli psichiatri Velasquez e Mendez nonché di Maria e della suora Belen rivelano il valore condiviso - anche dalla Grandes - del rispetto della dignità umana qualunque siano le condizioni psico-fisiche e sociali della persona, anche di fronte alle disabilità.
Il romanzo vuole esortare alla memoria, soprattutto le generazioni che non hanno vissuto quell’epoca, per fare conoscere loro a fondo la brutalità e la repressione della dittatura. “Ci sono moltissime fosse comuni che potrebbero raccontarci tante altre storie non ancora conosciute”. Nel contempo vuole essere un ringraziamento per chi ha lottato per ottenere la democrazia e la libertà.
Almudena Grandes, La figlia ideale, Guanda, 2020
Le precedenti recensioni: