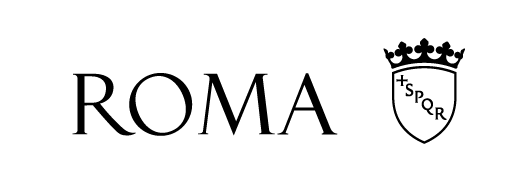martedì
16
marzo
giovedì
4
marzo
martedì
16
marzo
Il pianista
4 - 16 marzo 2021
Le recensioni di Anna Violati, coordinatrice del Circolo di Lettura
E’ un romanzo molto apprezzato da Camilleri che lo ha giudicato uno dei romanzi più belli tra quelli letti. Il primo ad individuare i meriti di
Manuel Vazquez Montalban è stato Leonardo Sciascia, che insieme alla giuria da lui presieduta ha voluto premiarlo con il premio Racalmare nel 1989. Questo libro inconsueto da un punto di vista strutturale, ci pone innanzitutto domande sulla funzione della memoria, dell’arte e del valore della coerenza. E‘ legato alle radici, alle vicissitudini dello scrittore, anche lui antifranchista, che ha scontato torture e prigione e che sente l’impegno di riscattare con la propria realizzazione le vite oscure dei suoi e della sua gente. Non ci sono soltanto riferimenti autobiografici al suo quartiere ma anche un’analisi della situazione politica, la sconsolata constatazione della fine di una ideologia e di una utopia. Il romanzo come un nastro cinematografico si snoda a ritroso, su tre piani temporali, partendo dalla Barcellona degli anni ’80 (prima parte), per passare al periodo degli anni ’40 (seconda parte), per finire con gli anni della gioventù del protagonista a Parigi nel 1936 (terza parte). Sul palcoscenico della Barcellona moderna è raffigurata, dentro bar alla moda e per le Ramblas, una cerchia di intellettuali di mezza età, che furono antifranchisti. Si scambiano battute pungenti (quasi duelli verbali), vivono occupati in attività culturali o come funzionari e sembrano accettare implicitamente il loro fallimento. "Tutti militavano nella comunione dei Santi Vinti, nella comunione di quel che poteva essere stato e non fu”. A scuotere le basi di quella società liberale catalana è un loro amico trapiantato a New York, la capitale dell’impero. E’ il prototipo di intellettuale europeo che, vissuto lontano dalla contaminazione franchista, ha potuto leggere tutto ciò che si pubblicava senza il vaglio della censura franchista. Tira su gli animi degli amici invecchiati, ma solo per un po', lasciandoli poi cadere nel “piatto della loro mediocrità”. Questo è ciò che Ventura, traduttore, in pessime condizioni di salute, pensa ed esprime a mò di parabola. Da notare che Ventura è il nome di battaglia di
Pepe Carvalho nella lotta antifranchista e che fa pensare che si celi dietro di lui lo stesso scrittore. Ventura è attratto dal pianista anziano, descritto come un "quattro" umano, che suona abilmente musiche di Mompou. Gli si avvicina ma nessuno dei due sembra rompere il silenzio che invece è rotto da Louis Doria, l’alter ego di Albert Rossel, il pianista, che lo loda chiamandolo per nome, fermandosi a due metri di distanza, “rispettoso della piccola patria di riposo e vecchiaia che circondava l’ometto". "Louis Doria scendeva le Ramblas maestoso seguito da uno strascico di spruzzi di stelle, veduto solo da Ventura e Rossel”, inseguito da giornalisti e persone che desideravano l’autografo. Il traduttore segue con lo sguardo il pianista che, percorse le Ramblas, si ferma in una casa di via Botella, dove l’attende una donna malata, immobile nel letto, che lui accudisce, lavandola e dandole cibo e medicinali. Nella stessa stanza della donna, di cui il lettore non conosce ancora l’identità, ci sono ninnoli, mobili, vari ritagli ingialliti di articoli di giornali riguardanti il musicista Louis Doria in diversi periodi, con premi, trofei, successi ai concerti alle Nazioni Unite. Nella seconda parte, nell'anno 1946, lo scenario è lo stesso, la prospettiva delle Ramblas, il triangolo isoscele tra Botella e piazza del Pedro (in cui lo stesso autore ha vissuto durante l’infanzia) ma visto dall’alto dei terrazzi dove d’inverno gli abitanti salgono a prendere il sole, d’estate a godersi il fresco. Sono persone dai più disparati mestieri, due ragazze, l’una venditrice di uova, l’altra guardarobiera in subaffitto; un allevatore di piccioni, un altro che alleva una capra; un ragazzo che si allena pensando di diventare pugile; Andres che è ritornato da un campo di concentramento; il signor Enriquez che vende giornali ma procura anche riviste e libri proibiti dalla censura. Si arrabattano per sopperire al razionamento, alla scarsità di risorse economiche. Lamentano la scarsità di cibo, furti di biancheria stesa e si chiedono come mai possa vivere il regime franchista in una Europa democratica. Tutti sognano di migliorare le proprie condizioni economiche, magari anche espatriando. Ogni famiglia ha subito la perdita di qualche congiunto ma non disdegnano di ballare e cantare al suono di musiche gitane. Sulla terrazza sale anche un uomo arrivato da qualche giorno, il pianista Rossel con capelli biondi ed un principio di calvizie, con occhiali tondi di tartaruga, in subaffitto dalla famiglia dell’aspirante pugile, uscito dal carcere da una settimana da San Miguel Rejes, dopo essere stato in altre carceri, anche alla Modelo. Ha fatto parte delle milizie del POUM dal 1937. Arrestato ha rischiato la pena di morte, commutata in 20 anni di carcere, di cui ha scontato 6 anni. Ottenuto l’indulto è costretto a presentarsi ogni 15 giorni in commissariato per tutti i 16 anni mancanti. E’ attratto da un foglio di giornale spiegazzato, una pagina di foto in un rotocalco: “Louis Doria accolto trionfalmente dalla critica di Chicago ripreso in marsina mentre riceve la bacchetta d’oro consegnatagli dalla figlia del presidente Truman”. Il musicista era tornato in Spagna dopo il ’42, aveva suonato a un festival musicale della Costa Brava, davanti allo stesso Franco. Rossel è accolto favorevolmente dal gruppo, che decide di aiutarlo a trovare un pianoforte per esercitarsi, visto che sono trascorsi 6 anni senza poterlo fare, di terrazzo in terrazzo, scendendo nei vari appartamenti e in contatto con altri abitanti, in particolare con un’indovina che lo indirizza dove trovarlo: nell’abitazione della signora Leonard, madre di Manon, una cantante di
zarzuelas che gli consente di suonarlo, anche se la figlia è per il momento assente. La musica di Albert attira una piccola folla sottostante i balconi, in strada, che sui marciapiedi ascolta e balla. Ma viene dispersa dalla polizia (nel settimo anno trionfale) dopo aver redatto un verbale. Andres esprime al pianista le sue opinioni e riflessioni sugli abitanti del quartiere, che magari possono pure criticare le azioni altrui, ma si sentono rassicurati dalla conoscenza reciproca. E’ rimasta tanta generosità in questa gente, che al mattino sentendo i vecchietti alle pianole, o i cantanti di canzoni catalane o la voce del gitano ombrellaio, lascia cadere una pioggia di monetine dai balconi. Gli piacerebbe sapere scrivere per raccontare tutto questo, perché nessuno lo racconterà mai, questa gente quando morirà, morirà del tutto. Sapersi esprimere, mettere per iscritto ciò che uno pensa e sente è come “spedire messaggi da un naufragio dentro una bottiglia per i posteri”. Ogni quartiere dovrebbe avere un poeta o un musicista affinché fra molti anni in certi musei speciali la gente possa rivivere grazie alla memoria. Un giorno tornerà dall’altra riva dell’orizzonte e con il suo successo darà dignità a queste vecchie cose, a questa gente sconfitta. Quando Manon Leonardi torna a casa, Rossel scopre che in realtà la bionda donna “cubica” è Teresa, l’amante di Louis Doria, conosciuta a Parigi anni prima (come noi lettori leggeremo nella parte finale). L’abbraccio tra i due molto commovente rimarrà a lungo nella memoria di Andres. Nell’ultima parte, nel 1936, il giovane ventiseienne pianista Albert è a Parigi con una borsa di studio. Ha molte speranze di diventare un grande pianista. Sogna le locandine delle sue tournees in tutte le grandi capitali del mondo. E’ ospite di Luis Doria, che è stato compagno di studi a Barcellona, insieme alla sua amante Teresa Leonard, che canta le
zarzuelas, sperando di diventare una grande soprano dell’Opera Comique. La promessa dell’amico di presentarlo al noto musicista e compositore Millhaud gli fa supporre che entro il ’38 sarebbe stato possibile incidere qualcosa di suo. Si immagina di suonare al Palau de la musica a Barcellona, con i suoi genitori e i suoi maestri in prima fila. Doria è un po’ opprimente e vorrebbe imporgli il suo modello di comportamento sprezzante e adattabile a tutte le situazioni, pur di conseguire il successo. Albert è felice di trovarsi a Parigi, nelle vie e nelle piazze più famose, si sente vivo, godendosi le passeggiate a piedi e finendo sempre a fermarsi a Saint German davanti alla statua di Danton, luogo di incontro col suo amico di partito Bonet. Il 14 luglio a Parigi c’è una grande manifestazione per l’anniversario della presa della Bastiglia. Ma nel giro di qualche giorno arriva la notizia dell’uccisione in Spagna di Josè Calvo Sotelo, leader dell’opposizione e via via del colpo di stato, della sollevazione dell’esercito d’Africa, dei tentativi di colpi di stato in diverse città spagnole. Si combatte per le strade di Barcellona e di Madrid. Corre voce che il generale Franco stia cercando di attraversare lo stretto a capo dell’esercito d’Africa. Rossel si sente ”soffocare da un istinto di sopravvivenza allo stesso tempo coscienza del mondo, disposto a lasciarsi uccidere per una idea o progetto di un’idea almeno mentalmente”. Alla notizia che a Barcellona ci sono sparatorie per la strada e che la gente va a cercare armi nelle caserme per difendere la Repubblica, decide insieme a Bonet ed altri compagni di tornare in Spagna al servizio del POUM. La Francia si dimostra pacifista ma nel senso di lavarsene le mani. Spesso sui muri era scritto ”Pas en guerre!", “un grido polivalente che in quel mattino del 20 luglio si rivestiva di un significato esclusivamente fascista, la libertà del mondo con un coltello puntato al collo, la punta di un coltello che premeva sulla carotide della Repubblica”. La stessa decisione di tornare é presa da Teresa e dallo svedese Larsen, amico e aspirante biografo di Doria, che invece si rifiuta, convinto che non sarebbe accaduto nulla, la guerra essendo in fondo “una battaglia di beduini”. “La statua di Danton sembra essere la statua rappresentativa di quella Parigi di fine luglio del 1936, guardava l’orizzonte”. Doria rimane convinto che la guerra sarebbe durata quattro settimane e non vuole perdere ”l’occasione ora che sta per raccogliere i frutti di una lunga semina”. In questa parte anche la musica assume una grande rilevanza e le discussioni sollevate intorno ad artisti come Satie, Eisler, Folla ed altri autori impressionisti, sulle correnti musicali in voga tra le due guerre, testimonia della vasta cultura dello scrittore anche in campo musicale. La Parigi del tempo, della speranza, è emblematica di quelle pulsioni che mossero la generazione del pianista (così come anche di Vazquez Montalban) a credere che un giorno si sarebbe conquistato il mondo e si sarebbe dato l’assalto al Palazzo d’Inverno, metafora di vita e non solo di politica. Nello scrittore c’è l’intento della riscoperta dei perdenti. Perdente è Rossel, tradito dai compagni di ideali politici e nella carriera. Perdente Teresa, cantante dei tranvieri, lontana per sempre dall’Opera Comique, costretta ad un’esistenza sofferta e vegetale, in mezzo ai suoi ninnoli e ai ritagli di articoli esaltanti Doria. Perdente anche quest'ultimo, seppure di successo, servo di una immagine fine a se stessa, che muta le proprie idee avanguardiste e accetta di suonare per Franco e diffonde la musica di regime. Perdente è anche Ventura, militante antifranchista tradito dalla storia, nato per scrivere e ridotto alla condizione di traduttore. Con loro sono perdenti anche i loro amici, che abbandonati i loro ideali si sono adattati alla mediocrità del ruolo di funzionari. Con questo romanzo Vazquez Montalban vuole garantire all’umanità sconfitta il diritto ad una esigua sopravvivenza, riscattarla con la dignità della memoria e con il potere redimente della pagina scritta.
Manuel Vazquez Montalban, Il pianista, Sellerio, 1998
Le precedenti recensioni: