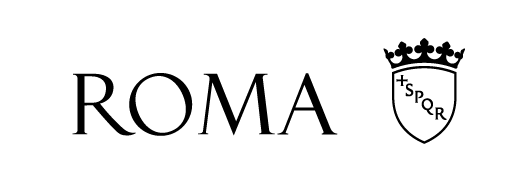mercoledì
24
febbraio
giovedì
28
gennaio
mercoledì
24
febbraio
Il pittore di anime
28 gennaio - 24 febbraio 2021
Le recensioni di Anna Violati, coordinatrice del Circolo di Lettura
Il pittore di anime di
Ildefonso Falcones è un romanzo corale, corposo, intenso, emozionante. La storia narrata è ambientata a Barcellona nell’arco temporale compreso tra il 1901 e il 1909, durante il regno di Alfonso XIII, periodo di profonda crisi economica per la Spagna, dovuta in parte alla rivoluzione industriale, soprattutto alle conseguenze per la guerra persa contro gli Stati Uniti e la perdita delle colonie di Cuba e delle Filippine. La trama ricca, ben intessuta con rocambolesche vicende, avventure, peripezie dei protagonisti ricorda i grandi romanzi dell’Ottocento (
I miserabili di Victor Hugo) con un epilogo, ventitre anni dopo (1932), che racconta lo sviluppo futuro della storia, di libertà, di riscatto, di rivalsa contro le sofferenze e le ingiustizie del passato. Le chiavi di lettura, o meglio le tematiche sono molteplici: l’amore, il femminismo, la passione per l’arte, le rivolte sociali, il contrasto tra la classe operaia anarchica-anticlericale e la ricca borghesia cattolica, l’ingiustizia, la vendetta personale, la perdita della dignità, che si fondono in un intreccio narrativo avvincente. Ma i temi predominanti oltre l’amore sono: l’esplosione dell’arte Modernista e la grande povertà cagione di tante lotte sociali del periodo a Barcellona. A guidare il lettore nel mondo dell’arte sarà il protagonista Dalmau Sala, pittore e ceramista, specializzato nei disegni sulle ceramiche ispirati ai motivi floreali giapponesi. Lavorava per la fabbrica di ceramiche di Don Manuel Bello. Figlio di un anarchico condannato a morte ingiustamente nella fortezza di Montjuic, è innamorato della bella e passionale Emma Tàsies, figlia anch’essa di un anarchico, ingiustamente arrestato e morto per le torture subite. Ma i percorsi di vita dei due fidanzati, inizialmente felici, si divideranno dopo l’arresto e la morte di Monserrat, sorella di Dalmau, ardente combattente contro le autorità e i preti, rei di convincere i poveri, con la promessa di ricompense nell’aldilà, ad accettare il loro destino di fame e di malattie. Il pittore cadrà nel pozzo più profondo della sventura, diventando dipendente della droga e dell’alcolismo, causando involontariamente la morte della figlia di Manuel Bello, che da quel momento diverrà suo acerrimo nemico. Superata la dipendenza, ”
l’arte, la magia, tornata negli occhi, nelle mani oltre che nello spirito”, gli consentirà di creare lavori straordinari che lo porteranno a conoscere i grandi maestri del Modernismo, l’arte che cambiò la fisionomia di Barcellona, con la realizzazione di strutture neogotiche con decorazioni naturalistiche e floreali. La città abbattuta la sua medioevale cinta muraria si sviluppò ulteriormente dal punto di vista urbanistico, gettando le basi di quei viali e di quei grandi palazzi all’altezza di città come Parigi e New York, che erano considerate all’avanguardia. L’alta borghesia volle edificare palazzi sontuosi dalle forme curve, irregolari, geometriche con nuove tecnologie, con il ferro piegato a diverse forme, con l’uso di ceramiche, rivestiti con mosaici con la tecnica di
trencadis, parte integrante. La pietra si trasformava in qualcosa di etereo con una
comunione di forme, di luci e di colori. La edificazione e la ristrutturazione degli edifici venne affidata ai grandi artisti dell’epoca: Gaudì, Doménech, Puig i Cadafalch. Gaudì fu l’architetto che realizzò opere come: la
casa Battlò, la
Pedrera e il
parco Gùell, iniziando le basi della
Sagrada Familia. Doménech progettava la
casa Leo Morera, il
Palazzo della musica catalana, i padiglioni dell’
ospedale di Sant Pau, mentre Joseph Puig i Catafalch costruiva la
casa Amatler. Attraverso gli occhi del protagonista (che collaborerà alla lavorazione), condividiamo le sue emozioni e quelle dello scrittore, ammirando il dragone che coronava la
casa Battlò, con ceramiche a forma di squame cangianti, la facciata con
trencadis: un mosaico di vetri e pietre colorate per simulare la superficie di un lago con onde e ninfee. Ci stupiamo di fronte alla
casa Pedrera, un edificio in cui la pietra della facciata, delle finestre, dei muri e delle colonne si manifestava in forme curve, dinamiche, sommandosi alla trama contorta del ferro battuto dei balconi, all’interno di spazi irregolari e labirintici dove Gaudì aveva voluto imprimere movimento alla pietra. Il
Palazzo
della musica di Doménech ci appaga di “
colori, forme, riflessi, metafore”. Soprattutto saremo abbagliati dal lucernario, un rettangolo di 60 metri quadrati, fatto di 1600 pezzi di vetri colorati, simile a un “
sole fiammeggiante,
coperchio dell’universo di luce”. L’auditorio era una teca di cristalli, migliaia di vetri piombati artistici che inondavano di luce variopinta il tempio della musica. La fantasmagorica bellezza del Modernismo ispirerà Dalmau a dipingere “La bottega dei mosaici” che, ammessa a partecipare alla quinta Esposizione Internazionale di belle arti e industrie artistiche, non fu esposta per disposizione dei Lucks, che lo ritennero osceno per un nudo contenuto. Ciò lo accese d’ira tanto che sulle prime non volle più dipingere. In seguito considerando che "
l’arte appartiene al popolo e deve essere diffusa e goduta
gratuitamente", decise di dipingere tre quadri per la Casa del Popolo, in cui comparivano istituzioni religiose date alle fiamme, con l’obiettivo politico di infiammare e sollevare il popolo contro la Chiesa. Come netto era il contrasto tra gli edifici lussuosi di Avenida Diagonal e l’agglomerato disordinato di costruzioni anonime nel quartiere popolare di Saint Antoni, così c’era una disparità di vita tra il benessere della ricca borghesia e la miseria delle condizioni delle classi operaie, che scendevano in piazza per reclamare con scioperi e manifestazioni i propri diritti. In quei primi anni del 1900 in cui non c’erano ancora i sindacati, i lavoratori erano divisi in movimenti repubblicani d’ispirazione socialista e anarchica e si battevano per la giornata di otto ore, il riposo festivo, soprattutto per l’aumento del salario che, per alcune categorie, era veramente da fame. Ma la classe dirigente e padronale, appoggiata dal clero, non era disposta a nessuna trattativa, sfruttava i crumiri, coloro che per poco erano disposti a lavorare nei giorni di sciopero generale, vanificandone i risultati. Cresceva così anche la disoccupazione dopo ogni sciopero. Spesso erano le donne a manifestare, infatti Emma Tàsies, l’altra protagonista, incarna lo spirito battagliero delle donne. Combattiva, oratrice persuasiva, all’interno del partito repubblicano era diventata una dirigente dei giovani “barbari”, gruppo di attivisti radicali (tra i sedici e venti anni), di cui il repubblicano Lerroux si serviva come milizia contro gli oppositori e contro la Chiesa. L’attività di Emma si esercitava con l’appoggio agli scioperi e alle manifestazioni, a qualsiasi iniziativa a difesa dei diritti degli operai, istigando i cittadini a ribellarsi contro le ingiustizie dei padroni e dei preti, rei questi ultimi di promettere una ricompensa nell’aldilà, di scarsa utilità nei casi di malattia e di fame. Poiché aveva bisogno dell’apporto attivo delle donne, il compito di Emma era quello di provvedere anche all’istruzione delle donne (al grido:
la conoscenza rende liberi) lottando contro la passività femminile soprattutto delle casalinghe e delle domestiche. Il suo attivismo sociale e politico non verrà meno anche quando è costretta a svolgere diversi e umili lavori e a perdere la sua dignità, vendendo il suo corpo per riuscire a sfamare la figlia Giulia, avuta dal muratore Antonio, morto per il crollo di un’impalcatura di un edificio in costruzione. In prima fila a sprezzo del pericolo, è anche nelle rivolte e nei tumulti, negli incendi di quella che passerà alla storia con il nome di
settimana tragica, dal 26 luglio al 3 agosto 1909, perché le autorità ponessero fine alla guerra nel Sud-Africa per cui erano stati reclutati soldati riservisti e che veniva sbandierata come guerra patriottica. In realtà la guerra in Africa era stata voluta dalla ricca borghesia contro i berberi per poter continuare a sfruttare le miniere di ferro e le ferrovie. A esclusivo beneficio delle compagnie di assicurazione e dei loro azionisti venivano inviate truppe composte da riservisti del 1903 che, liberi dal servizio militare erano sposati con figli. La loro partenza privava le famiglie dell’unico sostentamento economico a disposizione. Il ricorso allo sciopero generale del 26 luglio con l’interruzione del lavoro e la chiusura delle fabbriche, era ritenuto il mezzo di pressione più efficace. Operai da una parte, radicali e anarchici dall’altra insieme a socialisti e”catalanisti”, Barcellona si trasformò in una polveriera sul punto di esplodere. Sera dopo sera un distaccamento di polizia aspettava pronto a sparare in aria e a eseguire arresti. Lo sciopero generale, nato per chiedere la fine della guerra, sembrò l’inizio di una vera e propria rivoluzione, i repubblicani rivolsero la loro rabbia e il loro odio contro il nemico atavico responsabile di tutti i mali della società e che i loro dirigenti avevano accusato perfino della guerra: la Chiesa. Si cominciò a bruciare il Collegio dei Fratelli Maristi, la Chiesa di San Pau. In quella settimana tragica si verificarono altri incendi di istituti religiosi, scontri selvaggi sulle barricate difese da donne, spari di cecchini, lanci di bombe. Barcellona era diventata una città senza legge, caotica e pericolosa. Le masse organizzate, vittime dell’ingiustizia sociale, perseguitate dalla miseria non indirizzarono le loro proteste e la loro ira contro la classe dei potenti che continuavano i loro ricevimenti anzi rispettarono il patrimonio, le case, le industrie e i negozi. Furono rispettate anche le vite dei religiosi, fatti uscire prima dell’incendio, anche se insultati, maltrattati, aggrediti. L’odio era rivolto alle istituzioni religiose. Il 30 luglio la calma tornò nella città, erano giunte truppe di soldati di rinforzo da ogni parte della Spagna. Ai soldati era stato raccontato che dovevano sedare una rivolta dei separatisti catalani. Il 2 agosto furono riaperte fabbriche, botteghe e negozi e fu stabilito, per evitare altre proteste e sommosse, di pagare agli operai i soldi corrispondenti alla settimana della rivolta. Ma il tragico bilancio di quella settimana fu l’incendio di 80 edifici religiosi, tra cui 33 scuole , 14 chiese e 30 conventi, la morte di 104 civili tra uomini e donne, il ferimento di centinaia di persone, mentre l’esercito, compresa la Croce Rossa e la polizia, aveva subito 8 morti e un centinaio di feriti. Ma quella settimana tragica ebbe anche un’altra conseguenza: accelerò il declino del movimento artistico, perché l’afflato di libertà che lo ispirava venne accusato di aver fornito il substrato ideologico alla rivolta.
Un’altra donna di rilievo nel romanzo è Josefa, la madre sarta di Dalmau. Logora la sua salute cucendo a macchina fino a notte inoltrata per mantenere i suoi figli. Offre il suo contributo affettivo ed economico a Emma accogliendola con la figlioletta nella sua casa. E’ lei a subire la vendetta di Don Bello che le fa revocare l’aiuto economico della Chiesa, richiesto contro i suoi principi anarchici per necessità. L’imprenditore le sequestra anche tutto quello che aveva in casa, compresa la macchina da cucire, per recuperare il denaro speso per l’esonero dalla leva militare del figlio. Altra figura femminile importante è la
trinxeraire Maravillas con il fratello Delfin, i cui visi ritratti da Delmau lo avevano consacrato come “pittore di anime”. Sarà la piccola ragazzina di strada che come un
deus ex machina farà evolvere gli eventi anche se in modo ambiguo: inizialmente salvando il pittore, di cui s’invaghisce, dalla droga, poi gelosa di Emma, provocando la morte del compagno. In seguito tradisce Dalmau consegnandolo alla giustizia,lo ”vende e rivende” al losco trafficante e ricettatore Don Ricardo, abitante nella baraccopoli di Pekin. Ma alla fine rivelerà a Emma, perché lo liberi, il nascondiglio in cui il “trafficante” lo teneva prigioniero, pronto a consegnarlo, in cambio di denaro, all’autorità e alla vendetta di Don Bello. Maravillas e Delfin sono gli archetipi di circa diecimila ragazzi di strada che vivevano in quel tempo nei bassifondi di Barcellona approfittando delle debolezze umane, mentendo e rubando per sopravvivere.
“Il pittore di anime” è un grande affresco di un’epoca convulsa, nel quale l’amore, la passione per l’arte, le rivolte sociali, la perdita di dignità, la voglia di riscatto, le vendette personali, si fondono in un intreccio emozionante, sullo sfondo di una Barcellona che si ribella al grigiore dei Lucks, disponibile ai colori, alla fantasia e alla creatività dell’arte modernistica.
Ildefonso Falcones. Il pittore di anime, Longanesi, 2019
Le precedenti recensioni: