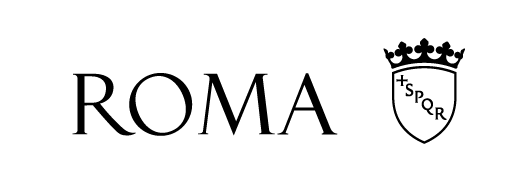martedì
30
marzo
mercoledì
17
marzo
martedì
30
marzo
La piazza del Diamante
17 - 30 marzo 2021
Le recensioni di Anna Violati, coordinatrice del Circolo di Lettura
L’opera letteraria di
Mercè Rodoreda è senz’altro un’importante testimonianza degli anni più bui del secolo XX° spagnolo. Ha ritratto personaggi femminili densi di poesia e pathos, simboli del processo socio-culturale involutivo che colpì le donne spagnole dalla fine degli anni Trenta. Le protagoniste dei romanzi rodorediani del dopoguerra sono modelli della perfetta moglie e madre promossa dal regime franchista, impegnata nella lotta per la sopravvivenza, in un mondo maschile, rappresentazione della forza negativa che impedisce la loro realizzazione personale. Nella maggior parte dell’opera narrativa, in cui si fondono memorie personali e memoria collettiva, la scrittrice mostra l’intenzione di denunciare l’annientamento dell’identità femminile, la perdita dei diritti vitali e tutte le forme di violenza fisica e psicologica contro le donne, attuate dal regime e da una società patriarcale. Presente è anche la guerra ma come elemento della quotidianità vissuta. Non ci sono descritte scene di battaglia, di bombardamenti, di rastrellamenti franchisti, soltanto il dramma umano operato dalla guerra civile nella tormentata esistenza delle sue creature. Avvincente è la tecnica espressiva di Mercè Rodoreda, in cui l’io narrante con un lungo monologo quasi parlato sa condurci dentro la storia. E’ un flusso di coscienza che ricorda Virginia Woolf, tuttavia Natalia/Colombetta è una donna semplice di modesta cultura. Con maestria l’autrice usa lo stile indiretto libero, con periodi brevi, con un loro ritmo e musicalità, con coinvolgenti similitudini e l’utilizzo di un linguaggio fonosimbolico, onomatopeico (
ah,
ah! per la risata;
brum, brum! per la moto). Riesce così a trasformare il lettore in un confidente che vive le angosce e le sofferenze dei personaggi, semplicemente attraverso la parola, i simboli e le immagini. Si avverte anche l’influenza di Proust: il tempo avanza impassibile, il ricordo del passato si converte in angoscia a causa dell’impossibilità di recuperare il tempo perduto. Compare tuttavia la speranza del futuro, il desiderio del futuro rappresenta il superamento del presente e del passato che va estinguendosi. La storia della protagonista si sviluppa tra realismo e simbolismo, strumento letterario, insieme a ironia e drammaticità, usato molto da Mercè Rodoreda nelle sue opere. Attraverso la sua prospettiva e il suo punto di vista vediamo uno scorcio di mondo, a partire da piazza del Diamante a Barcellona, simbolo di un universo racchiuso nel cerchio vita-morte-rinascita. Il personaggio di Quimet, marito di Natalia, che la ribattezza con il nome di
Colombetta, annullando la sua identità, è descritto con una sottile e persistente vena ironica, tanto che il suo maschilismo, diviso tra il dire e il fare, diventa caricaturale. A parole è il padrone che vuole che la moglie si uniformi a tutto il suo modo di pensare. Nei fatti la donna conserva nel silenzio delle sue riflessioni un’attenta capacità di critica e di discernimento nei confronti di molte decisioni prese dal coniuge, fino alla vendetta dei colombi. Per arrotondare lo stipendio Quimet aveva impiantato un allevamento prima sul terrazzo, poi addirittura in una stanza dell’appartamento, grazie a una botola. Le incombenze dell’allevamento, comprese le pulizie ricadevano interamente sulle spalle di Colombetta, che alla fine ossessionata dai colombi, che si riproducevano con tanta celerità, ne scuoteva le uova in cova tanto da uccidere i pulcini che si andavano formando al loro interno. E’ un atto di ribellione per la sopravvivenza, perché troppo stanca tra accudimento dei figli (Antoni e Rita) e del marito, e lavoro esterno come domestica. Tutto andava così ”con piccoli grattacapi”, finché venne la Repubblica e Quimet si esaltò e andò per le strade gridando e sventolando una bandiera, e i ”grattacapi” divennero grandi. Il lavoro di Quimet andava male e nel frattempo egli entrava nei gruppi d’azione. In seguito partì per il fronte d’Aragona, da cui ogni tanto tornava con provviste per i figli e la moglie. Natalia puliva gli uffici del municipio e a causa della guerra aveva sempre meno cibo da dare ai figli, tanto che decise di mandare il piccolo Antoni in colonia dove avrebbe ricevuto cibo a sufficienza. Il giorno che arrivò la notizia della morte di Quimet, moriva nella soffitta anche l’ultimo colombo con le lunette. Natalia divenne “di sughero e il cuore di ghiaccio. Giovani e vecchi tutti in guerra e la guerra li succhiava e li faceva morire.” Senza lavoro fu costretta a vendere tutto quello che aveva per ricavarne soldi per sfamare i suoi figli. Grazie alla signora Enriqueta, amica e confidente, trovò lavoro in una portineria a lavare le scale ogni sabato, e a pulire due volte la settimana una sala cinematografica: ”era una goccia nel mare”. Natalia e i figli erano stremati dalla fame. Il racconto della donna si fa sempre più drammatico. Per non vederli morire di fame, aveva l’intenzione, con l’imbuto del marito infilato in bocca, di versare loro dell’acido muriatico e poi di versarlo a sé stessa. Avrebbe acquistato l’acido dal droghiere dove comprava la veccia per i colombi, fingendo di aver dimenticato il denaro a casa. La notte precedente all’acquisto dell’acido, dopo due giorni che non mangiavano, Natalia ha un incubo: mani gigantesche afferravano i bambini diventati uova di colombi, li sollevavano e li scuotevano con rabbia. Il capitolo XXXVI è veramente un capolavoro: dalla disperazione e dall’incubo si passa al superamento quasi trasognato dell’orrore. Il droghiere aveva capito che la donna stava vivendo un grave momento e le offriva un lavoro di domestica a casa sua e del cibo per i figli. Dopo alcuni mesi le chiese di sposarlo, aggiungendo che aveva bisogno di una famiglia già fatta poiché la guerra l’aveva evirato. Natalia accettò dopo qualche esitazione e dopo il matrimonio si trasferì nella casa “rinnovata” di Antoni, il droghiere che le consentiva di avere una domestica e trattava con affetto i suoi figli come se fossero i propri. A poco a poco, pur con fatica, ”familiarizzava con le cose e la casa”. Viveva chiusa in casa perché aveva paura di attraversare la strada (simbolo della nuova vita). La casa - così come il giardino - per le donne rodorediane è come un rifugio protettivo che permette loro di isolarsi dalla realtà esterna, al punto che uscire procura loro malessere. La notizia riferita dalla figlia Rita, nel giorno della sua comunione, che il padre di una sua amica, creduto morto, era ritornato dalla guerra dopo anni di carcere, la gettava nell'angoscia. Era possibile che anche Quimet potesse ritornare vivo e vedendola sposata ad un altro uomo, “avrebbe messo a fuoco tutto”. Per questa paura, che le durò due o tre anni, non dormiva e non mangiava, finché spinta da tutti a uscire di casa, se ne andava per i parchi, evitando le strade dove passavano le automobili perché le venivano le vertigini. Nei parchi raccontava a qualche signora che in passato aveva avuto dei colombi in una torretta fatta costruire apposta dal marito, su cui, con la guerra, era caduta una bomba, distruggendo tutto. Così diventava nota come la "signora dei colombi", che viveva nel loro rimpianto. Trascorse il tempo, “vide cadere molte foglie e nascere molti germogli”, con il passare degli anni la smania di parlare dei colombi con le signore dei parchi le andava passando. Ma ancora non aveva fatto i conti con il proprio passato. Alla festa seguita al matrimonio della figlia Rita, salutata da tutti come signora Natalia, presa consapevolezza di sé stessa come Natalia, decise di chiudere con il passato come Colombetta. Come la signora Enriqueta le aveva detto, aveva come tutti ”molte vite, l’una intrecciata all’altra, che si azzuffavano tra loro e ci tormentavano, ma che una morte o un matrimonio qualche volta le separava e allora la vita vera, libera da tutti i fili della vita misera che l’avevano legata, poteva vivere come avrebbe potuto vivere da sempre”. All’alba tornò alla vecchia casa - “mi incamminai nella vecchia vita” - dove avrebbe voluto salire per toccare ancora una volta le bilancine della carta da parati, ma non le riuscì, nonostante alcuni tentativi, di aprire il portoncino. Allora con il coltello a grandi caratteri vi incise il nome
Colombetta, quasi a suggellare la fine di un tempo ormai passato. Arrivata a Piazza del Diamante, “una cassa vuota fatta di case vecchie con il cielo per coperchio, il cui foro si andava restringendo e prendeva forma di imbuto, dove mulinava un vento di tempesta”, lanciò un urlo d’inferno che portava dentro da anni. E’ un momento catartico, l’atto risolutivo, con cui uccide un passato morbosamente oppressivo, riuscendo così a trovare la sua identità e serenità. Tornata a casa si addormentò con Antoni, “sul letto caldo come la pancia di un canarino”, come se fossero due angeli del cielo. L’affetto del secondo marito, la tranquillità del presente fa risalire la protagonista alla vita, alla comprensione di sé e alla capacità di riguardare indietro senza paura e “di attraversare la strada.” Con una toccante intensità Natalia più che raccontare sembra suggerire attraverso i dettagli i suoi sentimenti, la sua fragilità e complessità. I sentimenti e le emozioni, i pensieri vengono catturati in una immagine che conferisce loro fisicità, perfino gli odori. L’odore serve da ancoraggio alla realtà, e insieme esteriorizzazione del pensiero interiore. L’odore del terrazzo con i colombi insieme all’imbuto hanno sì una fisicità ma come connotato negativo. Mentre le bilancine e le bambole sembrano essere le madeleine proustiane, simboli di un passato felice. Da sottolineare che le opere della Rodoreda sono scritte in lingua catalana, violando la legge franchista che aboliva l’autonomia della Catalogna e ne proibiva l’uso della lingua. Il mantenimento del catalano rappresentava per la scrittrice la patria e la sua identità. La lingua madre e la scrittura furono i fondamenti della sua resilienza, un’ancora per sopravvivere a una vita segnata dalla guerra, dalla miseria e dalla solitudine.
Mercè Rodoreda, La piazza del Diamante, Bollati Boringhieri, 1990
Le precedenti recensioni: