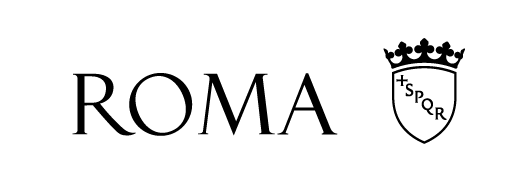martedì
7
settembre
Letteratura israeliana, letteratura palestinese
28 luglio - 7 settembre 2021
Due culture a confronto, come viste dai nostri lettori
La recensione di oggi per la rubrica
Letteratura israeliana, letteratura palestinese racconta di un libro edito nel 2016 da Feltrinelli, "Nel blu tra il cielo e il mare", il secondo romanzo di Susan Abulhawa, di cui sono stati venduti i diritti in diciannove lingue diverse già prima della sua uscita.
L’autrice, palestinese americana e nata nel 1970 in Kuwait, è fortemente attiva nella promozione dei diritti dei palestinesi, anche come fondatrice dell'organizzazione non governativa Playgrounds for Palestine.
Letteratura israeliana, letteratura palestinese con questa recensione vi augura buone vacanze e vi dà appuntamento a settembre, come sempre ogni mercoledì. Se anche voi desiderate inviarci una recensione scrivete all’indirizzo ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it.
L’autrice, palestinese americana e nata nel 1970 in Kuwait, è fortemente attiva nella promozione dei diritti dei palestinesi, anche come fondatrice dell'organizzazione non governativa Playgrounds for Palestine.
Letteratura israeliana, letteratura palestinese con questa recensione vi augura buone vacanze e vi dà appuntamento a settembre, come sempre ogni mercoledì. Se anche voi desiderate inviarci una recensione scrivete all’indirizzo ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it.
Questo secondo romanzo di
Susan Abulhawa ricalca in parte le tracce di “Ogni mattina a Jenin”, sua opera prima. Anche qui c’è la saga di una famiglia palestinese, in cui uno dei componenti, Khaled, bambino, muore all’età di dieci anni. La traccia del romanzo è ancora un villaggio palestinese, Beit Daras, sulla strada che porta dalla Palestina al Cairo. L’epoca è intorno al 1948.
Da Beit Daras si muove la storia della famiglia, ed è Khaled a narrarla, prima di morire – o come dice lui, prima di passare “nel blu”, frase che caratterizza gli svenimenti o lo stato di coma di una persona, o – per dirla con i protagonisti della storia – lo spazio-tempo degli spiriti. Una premessa storica dell’autrice, seguita dall’avvio della narrazione da parte di Khaled, aprono il libro.
La narrazione di Khaled inizia da quella che lui chiama “l’epoca dei tunnel”: questi tunnel venivano scavati tra Palestina ed Egitto al tempo della guerra del 1948, e servivano perché, avendo gli israeliani confinato i palestinesi nella striscia di Gaza, loro non potevano approvvigionarsi di ciò che volevano. Così, tramite questi tunnel, riuscivano ugualmente ad avere tutto quanto serviva loro dall’Egitto.
Dalla descrizione della famiglia emerge subito che la personalità di spicco della famiglia è – nelle parole di Khaled – sua nonna Nazmiyeh, che praticamente ha atteso ben undici figli maschi prima di avere la tanto desiderata femmina, alla quale aveva dato il nome di Alwan. La figlia femmina la desiderava da quando aveva perduto sua sorella Mariam, uccisa durante uno dei soliti attacchi israeliani. Khaled, nel parlare di sua nonna, inizia con una cosa che la nonna andava dicendo spesso: lei era la ragazza più bella di tutta Beit Daras. Alwan è la madre di Khaled. La bisnonna di Khaled, Umm Mamduh, era detta “la pazza”, poiché viveva sola, con due figlie e un figlio: il marito l’aveva lasciata.
Vorrei procedere con ordine, cosa che non ho fatto finora. Il romanzo è articolato in sette parti, ciascuna divisa in un certo numero (molto variabile) di capitoli. Questi iniziano sempre con una premessa di Khaled (che fino ad un certo momento è l'io narrante). Per distinguere queste premesse dal romanzo vero e proprio, esse sono in corsivo, e ancora in corsivo sono i capitoli dove è solo Khaled a raccontare. Le premesse sono una specie di anticipazione di quanto il capitolo contiene, ma la regola non è sempre valida. I titoli delle parti, invece, costituiscono una specie di guida alle storie che i capitoli raccontano.
La storia della famiglia Baraka (letteralmente “Benedizione”) è – a mio personale parere – abbastanza autobiografica dell’autrice, almeno in alcune vicende. Anche nel primo romanzo ho avuto la stessa sensazione, ma qui le cose sono più complesse. Otre alla sorella Mariam, Nazmiyeh ha un fratello, Mamduh, che, sempre durante la guerra del 1948, comincia a lavorare e per lavoro si trasferisce in Kuwait. Mamduh sposa Yasmine, moglie acquisita che proveniva da una famiglia di apicoltori, e da essa ha due figli, un maschio – Muhammad, come il nonno materno – e una femmina, Nur. Nel bel mezzo della guerra Mamduh – che si teneva sempre in contatto con la sua famiglia (in particolare con sua sorella) – la informa che presto si trasferiranno negli Stati Uniti, nella Carolina del Nord.
Anche dagli Stati Uniti, Mamduh telefona spesso alla sorella in Palestina. Le sue vicende occupano la seconda parte, e la fuga verso gli Stati Uniti la terza. Queste vicende sono piuttosto drammatiche: il figlio Muhammad muore in un incidente d’auto.
Nur miete successi negli Stati Uniti, a scuola e nella vita. Nel frattempo sua madre muore, e il padre invecchia, avendo sempre in mente di tornare in Palestina. Quando sta per farlo, si ammala, viene ricoverato in ospedale, dove muore. Prima di morire, preoccupato della sorte di sua figlia, Mamduh aveva parlato con un’assistente sociale, che gli era stata mandata, di origini africane, il cui nome era Nzinga. Costei gli aveva promesso che si sarebbe occupata di Nur. Nur resta sola, e viene affidata ad una famiglia, con padre americano, Sam, e madre di origine ispanica. Costei accetta di occuparsi di Nur, su richiesta di Nzinga, ma soprattutto per un fondo fiduciario, che le garantiva una entrata economica. Però non avrà mai gran simpatia per Nur. Nzinga però, visto il carattere della madre adottiva, la trasferisce in un istituto per l’infanzia (Mills Home). Qui, Nur riesce a studiare, ad andare al college, prende una laurea e diventa presto una psicologa affermata.
Intanto a Gaza, ad Alwan e marito nasce una bimba, oltre Khaled. Viene chiamata Rhet Shel, in ossequio ad un’americana molto brava e bella che si era stabilita per un certo tempo a Gaza, e che si chiamava Rachel Corrie. Le famiglie riescono a sopravvivere all’isolamento in cui Israele le tiene aiutandosi con la pesca. Khaled compie dieci anni, età importante per un bambino arabo, perché passa da un numero ad una cifra, ad uno a due cifre. Nel frattempo il padre di Khaled e Rhet Shel rimangono uccisi nel bombardamento di Gaza ad opera degli Israeliani.
Ma – proprio quando Khaled avrebbe dovuto essere più contento – successe che “entrò nel blu”. Uno stato di coma particolare, in cui lui riusciva a percepire quello che gli accadeva intorno, ma non poteva comunicare con gli altri. Una prima volta riuscì a risvegliarsi quando suo padre, che lo aveva schiaffeggiato e non l’aveva visto tornare in sè, voleva portarlo in ospedale. La seconda volta, però, Khaled non si svegliò. Fu chiamato un medico, il dottor Jamal Musmar, il quale non poté che constatare come il bambino non rispondesse altro che con un battito di palpebre a quello che gli veniva chiesto. Fortuna volle che il dottor Musmar andasse in America per tenere una conferenza, e a questa assistesse Nur. Lei aveva riconosciuto in un video un bimbo (Khaled, che aveva un ciuffo di capelli bianchi) e così, parlandone con il dott. Musmar, pian piano arrivarono alla conclusione che il bimbo soffriva di un malanno che Nur conosceva (sindrome locked-in). Così tra una cosa e l’altra il dottore le propose di venire a Gaza.
Nur – come Mariam, la sorella di nonna Nazmiyeh – aveva occhi di colore diverso, ed aveva scelto di indossare lenti a contatto proprio per non apparire “uno scherzo di natura”. Arrivata a Gaza, accolta dal dottor Musmar, lei torna in famiglia, dove nonna Nazmiyeh ritrova nei suoi occhi quelli di Mariam. Inizia a curare Khaled, ma nello stesso tempo ritrova la sua famiglia e fa amicizia con la nipotina Rhet Shel. Purtroppo – nonostante i promettenti miglioramenti, Khaled non si riprende. E – come già detto – muore. Nur, avuta notizia che Nzinga era tornata in Egitto, la va a trovare. Poi torna a Gaza, ove, nel frattempo, sta accadendo un fatto nuovo. I palestinesi avevano catturato un soldato israeliano, e per il suo riscatto, chiedono la liberazione di mille prigionieri palestinesi: tra questi si trova anche l’altro figlio di Nazmiyeh, Mazen, il primogenito, che era stato catturato e imprigionato da Israele in uno dei suoi raid. Sua madre era sempre andata a trovarlo, ma solo ora che tornava a casa, prese ad essere felice. E per festeggiarlo, organizza un pranzo, che conclude il romanzo.
Le vicende di questa famiglia, che – come ho già detto – ricordano quelle della famiglia di “Ogni mattina a Jenin”, sono più complesse, ma in più passaggi ricordano quelle dell’altro libro. Ciò nonostante, questo libro ha un qualcosa di più avvincente, e – nello stesso tempo – più triste del precedente. Anche di questo romanzo bisogna dare atto alla Abulhawa della sua testimonianza sulla condizione del popolo palestinese, cacciato dalle sue terre. Chiedo scusa per non aver saputo sintetizzare queste vicende maggiormente, e consiglio a tutti la lettura di questo libro, come ulteriore testimonianza della condizione palestinese.
(Lavinio Ricciardi)
Da Beit Daras si muove la storia della famiglia, ed è Khaled a narrarla, prima di morire – o come dice lui, prima di passare “nel blu”, frase che caratterizza gli svenimenti o lo stato di coma di una persona, o – per dirla con i protagonisti della storia – lo spazio-tempo degli spiriti. Una premessa storica dell’autrice, seguita dall’avvio della narrazione da parte di Khaled, aprono il libro.
La narrazione di Khaled inizia da quella che lui chiama “l’epoca dei tunnel”: questi tunnel venivano scavati tra Palestina ed Egitto al tempo della guerra del 1948, e servivano perché, avendo gli israeliani confinato i palestinesi nella striscia di Gaza, loro non potevano approvvigionarsi di ciò che volevano. Così, tramite questi tunnel, riuscivano ugualmente ad avere tutto quanto serviva loro dall’Egitto.
Dalla descrizione della famiglia emerge subito che la personalità di spicco della famiglia è – nelle parole di Khaled – sua nonna Nazmiyeh, che praticamente ha atteso ben undici figli maschi prima di avere la tanto desiderata femmina, alla quale aveva dato il nome di Alwan. La figlia femmina la desiderava da quando aveva perduto sua sorella Mariam, uccisa durante uno dei soliti attacchi israeliani. Khaled, nel parlare di sua nonna, inizia con una cosa che la nonna andava dicendo spesso: lei era la ragazza più bella di tutta Beit Daras. Alwan è la madre di Khaled. La bisnonna di Khaled, Umm Mamduh, era detta “la pazza”, poiché viveva sola, con due figlie e un figlio: il marito l’aveva lasciata.
Vorrei procedere con ordine, cosa che non ho fatto finora. Il romanzo è articolato in sette parti, ciascuna divisa in un certo numero (molto variabile) di capitoli. Questi iniziano sempre con una premessa di Khaled (che fino ad un certo momento è l'io narrante). Per distinguere queste premesse dal romanzo vero e proprio, esse sono in corsivo, e ancora in corsivo sono i capitoli dove è solo Khaled a raccontare. Le premesse sono una specie di anticipazione di quanto il capitolo contiene, ma la regola non è sempre valida. I titoli delle parti, invece, costituiscono una specie di guida alle storie che i capitoli raccontano.
La storia della famiglia Baraka (letteralmente “Benedizione”) è – a mio personale parere – abbastanza autobiografica dell’autrice, almeno in alcune vicende. Anche nel primo romanzo ho avuto la stessa sensazione, ma qui le cose sono più complesse. Otre alla sorella Mariam, Nazmiyeh ha un fratello, Mamduh, che, sempre durante la guerra del 1948, comincia a lavorare e per lavoro si trasferisce in Kuwait. Mamduh sposa Yasmine, moglie acquisita che proveniva da una famiglia di apicoltori, e da essa ha due figli, un maschio – Muhammad, come il nonno materno – e una femmina, Nur. Nel bel mezzo della guerra Mamduh – che si teneva sempre in contatto con la sua famiglia (in particolare con sua sorella) – la informa che presto si trasferiranno negli Stati Uniti, nella Carolina del Nord.
Anche dagli Stati Uniti, Mamduh telefona spesso alla sorella in Palestina. Le sue vicende occupano la seconda parte, e la fuga verso gli Stati Uniti la terza. Queste vicende sono piuttosto drammatiche: il figlio Muhammad muore in un incidente d’auto.
Nur miete successi negli Stati Uniti, a scuola e nella vita. Nel frattempo sua madre muore, e il padre invecchia, avendo sempre in mente di tornare in Palestina. Quando sta per farlo, si ammala, viene ricoverato in ospedale, dove muore. Prima di morire, preoccupato della sorte di sua figlia, Mamduh aveva parlato con un’assistente sociale, che gli era stata mandata, di origini africane, il cui nome era Nzinga. Costei gli aveva promesso che si sarebbe occupata di Nur. Nur resta sola, e viene affidata ad una famiglia, con padre americano, Sam, e madre di origine ispanica. Costei accetta di occuparsi di Nur, su richiesta di Nzinga, ma soprattutto per un fondo fiduciario, che le garantiva una entrata economica. Però non avrà mai gran simpatia per Nur. Nzinga però, visto il carattere della madre adottiva, la trasferisce in un istituto per l’infanzia (Mills Home). Qui, Nur riesce a studiare, ad andare al college, prende una laurea e diventa presto una psicologa affermata.
Intanto a Gaza, ad Alwan e marito nasce una bimba, oltre Khaled. Viene chiamata Rhet Shel, in ossequio ad un’americana molto brava e bella che si era stabilita per un certo tempo a Gaza, e che si chiamava Rachel Corrie. Le famiglie riescono a sopravvivere all’isolamento in cui Israele le tiene aiutandosi con la pesca. Khaled compie dieci anni, età importante per un bambino arabo, perché passa da un numero ad una cifra, ad uno a due cifre. Nel frattempo il padre di Khaled e Rhet Shel rimangono uccisi nel bombardamento di Gaza ad opera degli Israeliani.
Ma – proprio quando Khaled avrebbe dovuto essere più contento – successe che “entrò nel blu”. Uno stato di coma particolare, in cui lui riusciva a percepire quello che gli accadeva intorno, ma non poteva comunicare con gli altri. Una prima volta riuscì a risvegliarsi quando suo padre, che lo aveva schiaffeggiato e non l’aveva visto tornare in sè, voleva portarlo in ospedale. La seconda volta, però, Khaled non si svegliò. Fu chiamato un medico, il dottor Jamal Musmar, il quale non poté che constatare come il bambino non rispondesse altro che con un battito di palpebre a quello che gli veniva chiesto. Fortuna volle che il dottor Musmar andasse in America per tenere una conferenza, e a questa assistesse Nur. Lei aveva riconosciuto in un video un bimbo (Khaled, che aveva un ciuffo di capelli bianchi) e così, parlandone con il dott. Musmar, pian piano arrivarono alla conclusione che il bimbo soffriva di un malanno che Nur conosceva (sindrome locked-in). Così tra una cosa e l’altra il dottore le propose di venire a Gaza.
Nur – come Mariam, la sorella di nonna Nazmiyeh – aveva occhi di colore diverso, ed aveva scelto di indossare lenti a contatto proprio per non apparire “uno scherzo di natura”. Arrivata a Gaza, accolta dal dottor Musmar, lei torna in famiglia, dove nonna Nazmiyeh ritrova nei suoi occhi quelli di Mariam. Inizia a curare Khaled, ma nello stesso tempo ritrova la sua famiglia e fa amicizia con la nipotina Rhet Shel. Purtroppo – nonostante i promettenti miglioramenti, Khaled non si riprende. E – come già detto – muore. Nur, avuta notizia che Nzinga era tornata in Egitto, la va a trovare. Poi torna a Gaza, ove, nel frattempo, sta accadendo un fatto nuovo. I palestinesi avevano catturato un soldato israeliano, e per il suo riscatto, chiedono la liberazione di mille prigionieri palestinesi: tra questi si trova anche l’altro figlio di Nazmiyeh, Mazen, il primogenito, che era stato catturato e imprigionato da Israele in uno dei suoi raid. Sua madre era sempre andata a trovarlo, ma solo ora che tornava a casa, prese ad essere felice. E per festeggiarlo, organizza un pranzo, che conclude il romanzo.
Le vicende di questa famiglia, che – come ho già detto – ricordano quelle della famiglia di “Ogni mattina a Jenin”, sono più complesse, ma in più passaggi ricordano quelle dell’altro libro. Ciò nonostante, questo libro ha un qualcosa di più avvincente, e – nello stesso tempo – più triste del precedente. Anche di questo romanzo bisogna dare atto alla Abulhawa della sua testimonianza sulla condizione del popolo palestinese, cacciato dalle sue terre. Chiedo scusa per non aver saputo sintetizzare queste vicende maggiormente, e consiglio a tutti la lettura di questo libro, come ulteriore testimonianza della condizione palestinese.
(Lavinio Ricciardi)
Susan Abulawa, Nel blu tra il cielo e il mare, Feltrinelli, 2016
Le precedenti recensioni: