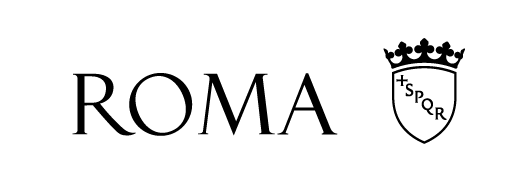domenica
4
aprile
lunedì
29
marzo
domenica
4
aprile
Bibliografia romana
29 marzo - 4 aprile 2021
Libri su Roma nelle recensioni dei nostri lettori
Questo libro non è soltanto un saggio, è un vero gioiello, sia per chi ama i libri, sia per coloro che nei libri cercano chiarezza e verità. E oltretutto è scritto in modo molto semplice, pur essendo ricchissimo di riferimenti storici, sia al periodo citato (1938-1943), sia ai problemi inerenti le persecuzioni razziali originate dalle leggi emesse dal regime fascista.
Prima di entrare nel merito del testo, debbo fare una doppia premessa. All’epoca di cui parliamo io avevo un anno di età (sono del 1937) e solo nel 1944, al ritorno a Roma da un lungo periodo passato nel Casentino (mio padre era dovuto fuggire l’8 settembre da Roma, e ci aveva fatti partire prima di lui), quando avevo sette anni, ho cominciato a sentir parlare di tedeschi e fascisti. Ricordo che nel giugno del 1944, appena tornati a Roma, mio padre ripuliva un cassetto, strappando molte cose. Tra queste, la tessera di “Figlio della lupa” intestata a me. Chiesi a mio padre il motivo delle distruzioni di quelle carte e lui mi rispose: “… capirai quando sarai più grande”. Anche a scuola (elementare e media, e poi al liceo) non trovai molti riferimenti storici sul periodo fascista e sui fatti che lo caratterizzarono. Solo molto più tardi, diciamo negli anni ’80, attratto da alcuni fatti che necessitavano di chiarimenti storici, approfondii la verità storica sul fascismo, sui suoi misfatti, e sulle persecuzioni degli ebrei.
La seconda premessa riguarda il mio pensiero sugli ebrei. Credo che – nel modo di pensare comune - la maggior parte di noi considera la parola “ebreo” come attinente alle credenze religiose (e non a fatti razziali o etnic
i). Per me – educato in maniera cattolica, ma con notevole libertà, dai miei genitori – il termine ebreo è solo un connotato religioso. Ho conosciuto molti ebrei nella mia vita: il relatore della mia tesi di laurea era Sergio Segre, figlio di un famoso matematico, Beniamino; un collega di lavoro del mio periodo romano (ho iniziato a lavorare a Milano) si chiamava Fabio Piperno e mi invitò spontaneamente al suo matrimonio nella sinagoga di Roma; infine, uno dei miei maestri di informatica era Roberto Vacca, anche lui figlio di un grande matematico. E queste tre citazioni sono soltanto quelle che ricordo con maggiore stima e ammirazione. Ho però chiaro, anche se non condivido minimamente questo aspetto, il fatto che la maggior parte delle persone comuni hanno ancora pregiudizi circa gli ebrei, simili a quelli che c'erano nell’”apartheid” sudafricana o nella questione delle persone di colore negli Stati Uniti e – immagino – anche del tipo ascrivibile ai fondamentalismi religiosi. Nel mio profondo non esiste alcun pensiero o atteggiamento simile a questi che ho citato, per me, nel novero delle libertà cui l’essere umano ha diritto, c’è la libertà di religione. Non esiste una questione razziale, l’unica razza cui l’uomo appartiene è quella umana.
Forse queste premesse sono un po’ lunghe e non del tutto chiare. Ma ho ritenuto importante farle.
Veniamo al libro. E’ un saggio storico, ed è corredato da quattro interventi di altri studiosi oltre le autrici, rispettivamente due presentazioni (di Giorgia Calò, assessore alla cultura della Comunità ebraica, e di Claudio Procaccia, direttore del dipartimento Beni ed Attività Culturali della stessa Comunità), una prefazione di Giacomo Saban, professore di geometria alla Sapienza, e l’introduzione di Mario Toscano, professore di storia contemporanea alla Sapienza. In tutte queste premesse si parla di aspetti delle Comunità ebraiche e dell’ebraismo, proprio – penso – con un occhio rivolto a chi non è ebreo.
Il saggio vero e proprio è diviso in due parti: la prima, “L’istruzione nella Roma ebraica (1938–1943)” è di
Giuliana Piperno Beer; la seconda, “La conquista del sapere: gli ebrei all’università. Testimonianze” è di
Silvia Haia Antonucci. L’ho letto in due tempi, prendendomi una pausa tra la prima e la seconda parte. Inoltre, alla fine ci sono una cronologia essenziale divisa in due tabelle, una consistente bibliografia e l’indice dei nomi.
Debbo dire subito che la prima parte è la più corposa e contemporaneamente la più bella. Il lettore si immerge progressivamente in questo bellissimo mondo, quello delle scuole ebraiche. Giuliana Piperno ci racconta come hanno fatto i cittadini ebrei romani a superare i divieti delle leggi razziali, costruendo scuole di tutti i livelli (elementari, medie inferiori e superiori, università – per quest’ultima, un istituto svizzero, a Friburgo, autorizzava corsi per corrispondenza, che in realtà furono tenuti a Roma dal prof. Guido Castelnuovo). Dopo l’introduzione delle leggi razziali, di cui se ne traccia l’iter con il succedersi delle azioni che hanno seguito la loro promulgazione, nei capitoli e paragrafi che seguono vengono descritte le maniere in cui la comunità ebraica seppe far fronte al divieto di istruzione (quest'ultima fondamentale per un ebreo). Una delle cose più toccanti che mi sono venute in mente mentre leggevo è stata immaginare un cittadino ebreo che – dalla sera alla mattina – non può più andare a scuola, lì dove andava sino al giorno prima.
Eppure, la tenacia di questo notevole gruppo di nostri concittadini si è data ragione di quello che accadeva, ed ha reagito nel modo che la Piperno ci descrive nei suoi tre capitoli (
La scuola elementare,
Le Scuole Medie Israelitiche,
Gli studi universitari). Proprio in questa accurata descrizione sta il valore del libro, ricchissimo di fotografie (nella prima di quelle riportate nel capitolo
Le scuole elementari, ho trovato come maestra di una prima la stessa maestra elementare di mio padre, che – ricordo bene – in quel periodo si era trasferita dalla Sicilia a Roma, proprio per lavoro, e ci venne a trovare a casa. Ricordo che abitava in un collegio sulla via Nomentana – “Stella Viae” –, sito tra via XXI Aprile e viale Gorizia, dove anche noi andammo più volte a trovarla).
Questa parte è ricchissima di notizie sui modi in cui le difficoltà di quel periodo, che andarono crescendo fino alle deportazioni del 1943-44, sono state affrontate e risolte, almeno in parte: Giuliana Piperno ha fatto ricerche approfondite, ricavandone notizie e fotografie che rendono la trattazione dell’argomento molto piana e scorrevole. Le fotografie consentono ai lettori di immedesimarsi nelle situazioni di quel tempo. Va detto, inoltre, che la Piperno ha insegnato Italiano nelle scuole statali, ed è quindi consapevole dei problemi che l’organizzazione di una scuola porta con sé: possono immaginare bene, quelli che – come me – hanno passato alcuni anni nel mondo della scuola, cosa avrà significato in quel periodo per gli ebrei dover supplire al divieto di istruirsi. Molto interessante risulta la parte sulle università, che riporta un bellissimo ricordo di una Università clandestina, organizzata principalmente dal prof. Guido Castelnuovo, insigne matematico, cui è intitolato l’Istituto Matematico della Sapienza di Roma, in collaborazione con il Politecnico di Friburgo, e nascosta sotto l’appellativo di “Corsi Integrativi di Cultura Matematica”. Ci furono anche altre due scelte, favorite dall’assenza di restrizioni per gli ebrei da parte vaticana: la Pontificia Università Lateranense e il Pontificio Istituto Biblico.
La seconda parte, di Silvia Haia Antonucci, ha una premessa abbastanza breve, che si riallaccia alla prima parte della Piperno. La Antonucci, oltre a premettere che solo il ricorso alle fonti orali consente di ricostruire l’iter curriculare di alcuni studenti universitari, ci racconta come in generale la tradizione orale – e di conseguenza la storia orale – sia stata un'ottima fonte per testimoniare come molti ebrei del periodo in esame siano riusciti nell’intento di conseguire una laurea, al pari dei loro colleghi non ebrei. Sviluppato tale tema, e approfondito il tentativo ben riuscito del prof. Guido Castelnuovo, coadiuvato dal collega Federigo Enriques, che organizzarono i Corsi Integrativi di Cultura Matematica, già citati dalla Piperno nel terzo capitolo della sua trattazione, la Antonucci ci consente di attingere direttamente alle fonti orali ancora in vita, riportando otto interviste, di cui cinque con studenti dell’Università clandestina e della Pontificia Università Lateranense, e tre con le figlie di personaggi già nominati nel testo, testimoni di queste scuole organizzate direttamente dalla comunità ebraica. Prima di riportare le interviste, la Antonucci fa una premessa metodologica per Emma Castelnuovo, prima delle intervistate, figlia di Guido Castelnuovo, insegnante nella scuola ebraica di via Celimontana, scuola ampiamente descritta dalla Piperno nella prima parte, per la quale si parla non di una vera e propria intervista ma solo di ricordi, riportati alla Antonucci in un colloquio, sintetizzati poi nel testo.
Sono andato fuori dai miei limiti abituali, dato l’entusiasmo e l’ammirazione che ho provato leggendo questo libro. Per completezza riporto i nomi degli intervistati: le interviste sono ampie testimonianze ricche di particolari. Gli intervistati sono: Gino Fiorentino, la sua è l’intervista più corposa, e vi si descrivono corsi e docenti dei Corsi Integrativi di Cultura Matematica, oltre a ricordi della scuola di via Celimontana e dell’Università clandestina; Ferruccio Sonnino (anche per lui si tratta del corso di Matematica), che dà un’idea di cosa venisse offerto a un ebreo che usciva delle Scuole Medie Superiori; Fabio Padovani (corso di Matematica), con un ricordo molto ricco di spunti diversi dai precedenti; Alessandra Cimmino (figlia del preside delle Scuole Medie Israelitiche di Roma dal ’39 al ’43, Nicola Cimmino), con una testimonianza originale e ricca di spunti esistenziali femminili sulla scuola diretta dal padre; Fabio Della Seta (studente della Pontificia Università Lateranense), anche questa testimonianza ricca di spunti esistenziali sul periodo; Mario Padovani (anche lui studente della Pontificia Università Lateranense), che racconta come l’Università lo aiutò a salvarsi durante le persecuzioni razziali dell’epoca; Anna Padovani (figlia di Paolo e nipote di Massimo Padovani, tutti studenti della Pontificia Università Lateranense), testimonianza anch’essa ricca di spunti esistenziali. Molti degli intervistati non hanno vissuto solo a Roma, ma provenivano da città diverse.
La vera bellezza di questo libro sta nell’unicità delle esperienze raccontate. È il più bel saggio che ho letto sulle difficoltà che gli ebrei romani ebbero durante il periodo indicato; è molto interessante per tutti, in particolare per coloro che non conoscono le vicende degli ebrei romani, ma anche per chi – come me – le ha approfondite attraverso fonti diverse e film trasmessi dalla Rai (non molto tempo fa ce ne fu uno, “Sotto il sole di Roma”, particolarmente efficace nel descrivere una storia svoltasi proprio nello stesso periodo).
È un libro che tutti dovrebbero leggere, e che permette di rispettare ed ammirare chi, a differenza di molti di noi, non ha avuto la vita facile ed è riuscito lo stesso a superare grosse difficoltà e ad affermarsi nel campo del sapere.
(Lavinio Ricciardi)
Silvia Haia Antonucci, Giuliana Piperno Beer, Sapere ed essere nella Roma razzista. Gli ebrei nelle scuole e nelle università (1938-1943), Gangemi, 2015
Le precedenti recensioni: