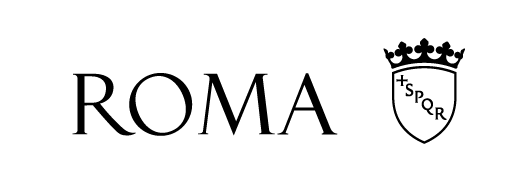domenica
21
marzo
martedì
16
marzo
domenica
21
marzo
Bibliografia romana
16 - 21 marzo 2021
Libri su Roma nelle recensioni dei nostri lettori
Il libro è un saggio storico, che racconta, con dovizia di particolari, come nacque e si sviluppò l’idea di erigere un monumento al filosofo di Nola, proprio nel luogo ove egli fu messo al rogo come eretico dal Sant’Uffizio.
Un saggio molto ben documentato (consta di 46 pagine di note e 15 pagine di riferimenti bibliografici), in cui la storia è riportata in forma di cronaca, da un autore estremamente attento a tutti gli sviluppi che la vicenda ha avuto negli anni. Si parte dal 1865, a Napoli, per arrivare ai nostri giorni. Per chi volesse studiare le vicende di fine Ottocento, il libro è un ottimo punto di partenza.
La storia di questo monumento si lega a doppio filo con la storia del movimento anticlericale, preesistente ai fatti che portarono alla sua costruzione, in riconoscimento del valore di filosofo attribuito al frate di Nola. Movimento fortemente contrastato dalla curia romana e dal papato dell’epoca, ma che nulla poté opporre al fatto che – nella seconda e decisiva fase – il movimento pro-Bruno potesse avere un potente sostenitore in Crispi, all’epoca capo del governo.
Chi scrive non è un grande amante della storia, ma – un po’ per la novità della vicenda, che dubito sia presente in molti libri di storia per i licei, un po’ per la semplicità e la chiarezza con cui l’autore racconta queste vicende – ha trovato interessante e per nulla faticosa la lettura di questo saggio.
Il tentativo di erigere questo monumento ebbe una prima tornata con una raccolta di fondi promossa da un gruppo di studenti della Università La Sapienza: questo primo tentativo, pur con il successo della raccolta, non andò a buon fine. Questo primo movimento fu quello dei cosiddetti “ragazzi del ‘76”, ed era capeggiato da due studenti, Adriano Colocci e Alfredo Comandini. Entrambi erano ferventi ammiratori del loro professore, Antonio Labriola. Durante questa fase furono eretti al Pincio 30 busti di italiani illustri, tra i quali figurò anche Giordano Bruno. Dopo questa iniziativa, Labriola e altri, tra i quali Pietro Cossa, Luigi Castellazzo e Raffaello Giovagnoli, scrittori abbastanza noti a quel tempo, portarono avanti il tentativo. Ad essi dette man forte un ebreo francese, Armand Levy. E l’iniziativa cominciò ad essere appoggiata dalla loggia massonica.
Purtroppo per i “Bruniani”, l’iniziativa ventilata del monumento ebbe tra gli oppositori proprio il Comune di Roma. Per ragioni di brevità, non entro nel merito di come l’iniziativa, che aveva prodotto una sottoscrizione internazionale pro-monumento, la si dovette abbandonare. Così, dopo questa prima vicenda che occupò circa quindici anni, si giunse alla costituzione di un secondo comitato, che, con alterne vicende, cominciò ad operare nel 1884. La ripresa delle iniziative fu promossa da uno studente bolognese, Giuseppe Vernazzi, che promosse assemblee studentesche e riaprì la sottoscrizione per il monumento. Ci vollero quattro anni di intensa attività e raccolta di nuovi fondi per raggiungere l’obbiettivo di affidare la costruzione della statua bronzea allo scultore Ettore Ferrari.
Considero il saggio di interesse non solo storico, ma anche etico e politico a un tempo: gli studenti, poi il comitato promotore, videro nel monumento a Giordano Bruno un incentivo alla libertà di pensiero e di espressione. E una volta che Francesco Crispi fu eletto a capo del governo, e che sponsorizzò l’iniziativa, sia la sottoscrizione che le adesioni formali fecero in modo che il 9 giugno 1889 la statua fosse inaugurata, al posto in cui figura oggi, in Campo dei Fiori. Decisiva fu – contro le opposizioni – la vittoria alle elezioni politiche del partito di Crispi.
Mi fermo qui: se quanto ho accennato interessa chi legge, lo invito a leggere il saggio. Sicuramente concorderà con me circa l’interesse che queste vicende suscitano in chi – non immedesimato nella vita dell’epoca – difficilmente potrà trovare traccia di questa vicenda in documenti ufficiali. Il rispetto delle autorità politiche – comunali e nazionali – per l’istituzione ecclesiastica non poteva incoraggiare una iniziativa che comunque era diretta contro il clero e il clericalismo allora imperante.
La storia della costruzione del monumento è ricca di particolari: nel basamento figurano otto medaglioni, con personaggi di spicco come Galilei, Campanella e altri “eretici”, tra cui Huss, altro filosofo che finì sul rogo. Anche qui, smetto di sottolineare particolari, perché solo la lettura del libro consente di avere una visione di assieme della vicenda.
Vicenda che l’autore continua a descrivere anche dopo l’erezione del monumento. La curia e il Papato non restarono indifferenti al monumento e cercarono in ogni modo di farlo abbattere. Per fortuna senza riuscirvi. L’autore arriva così a raccontare tutte le storie successive, fino al papato di Karol Wojtyla, primo papa che ammise la possibilità che la Chiesa avesse sbagliato nei confronti di Galileo e non solo.
L’opera di Bacciantini – che insegna storia della scienza all’Università di Siena – costituisce a mio parere un ottimo esempio di come narrare la storia di un episodio consenta di immaginare e addirittura quasi osservare i costumi esistenziali di un’epoca.
(Lavinio Ricciardi)
Massimo Bucciantini, Campo dei Fiori, Einaudi, 2015
Le precedenti recensioni: