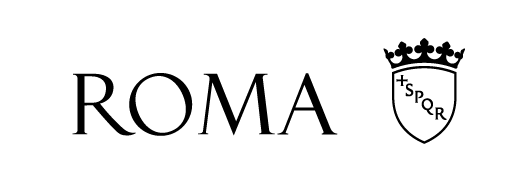Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
- Commenti
- Forse ti può interessare
Se vuoi inserire un commento a questo documento o indicare con un voto da 1 a 5 la tua preferenza inserisci il tuo codice utente e la tua password dal pulsante Accedi in alto a destra.
Non sei ancora un nostro iscritto? REGISTRATI ON-LINE!!
Non sei ancora un nostro iscritto? REGISTRATI ON-LINE!!
-
4 / 4 utenti hanno trovato utile questo commento14/03/2019
Quale futuro per la lingua italiana?
Gli autori di questo agile e gradevole saggio offrono innanzitutto un’interessante sintesi sull’evoluzione dell’italiano dal Trecento in poi e sulla sua diffusione all'estero nel corso dei secoli. Tra le varie informazioni sulla nostra lingua ne emergono alcune poco note come, ad esempio, il fatto che fino alla fine del Seicento i sultani ottomani comunicavano con i loro omologhi europei inviando lettere in turco con traduzione in italiano a cui le controparti rispondevano nella loro lingua nazionale ma sempre con traduzione in italiano. Vengono poi ricordate le ragioni della rapida ascesa dell'inglese come lingua veicolare internazionale dal secondo dopoguerra in poi. Di fronte alla concorrenza dell'inglese, tuttavia, la posizione dei due autori diverge. Per Graziosi, avendo ormai perso lo status di lingua di civilizzazione, l'italiano svolge solo il ruolo di lingua degli affetti e della comunicazione pubblica locale. Da questo punto di vista, egli condivide la scelta di alcuni atenei italiani di offrire corsi magistrali solo in inglese, specie nelle materie scientifiche e tecniche. Beccaria, invece, pur concordando sul ruolo egemonico dell'inglese, ritiene, con varie argomentazioni, che l'italiano possa e debba rimanere una lingua di civilizzazione utilizzata in tutti i rami del sapere. C'è un aspetto, tuttavia, che entrambi gli autori minimizzano: il crescente uso di anglicismi nell'italiano corrente, anche per esprimere concetti che non hanno alcun elemento di novità. Per Graziosi il fenomeno sarebbe trascurabile, mentre Beccaria, pur riconoscendo, con una lunga e divertente serie di esempi, che il fenomeno è molto diffuso, non ritiene che sia un pericolo per l'italiano. Egli rileva, peraltro, che in Francia e Spagna l'uso di termini inglesi è molto meno frequente rispetto all'Italia, sia perché si preferisce la loro traduzione in lingua locale, sia perché quelli inglesi vengono in gran parte "nazionalizzati" modificandone ortografia e grammatica. Egli, però, non spiega la ragione della passione italiana per gli anglicismi, probabilmente perché si tratta di un fenomeno più di natura psicologica che linguistica. Per quale motivo, solo per fare qualche esempio, sarebbe preferibile "newsletter" rispetto a notiziario o bollettino, "workshop" rispetto a laboratorio o esercitazione, "meeting" rispetto a incontro o riunione, “performance” rispetto a prestazione o esibizione, “provider” rispetto a fornitore o operatore e “fake news” rispetto a notizie false o disinformazione? La spiegazione più verosimile è l’esistenza nel nostro paese di un diffuso senso di subalternità rispetto al mondo anglosassone e, in particolare, statunitense, ritenuto in tutti i campi l’unico riferimento valido. Di conseguenza, per dimostrare di partecipare alla cultura dominante, s'infarcisce il linguaggio con termini inglesi anche quando non sarebbe necessario. Questa debolezza viene ampiamente sfruttata dalla pubblicità, dalla stampa, dalla politica e anche dalla pubblica amministrazione per cercare di ottenere maggiore attenzione o consenso, in quanto, ricorrendo ad espressioni inglesi, si ritiene di apparire più moderni ed efficaci. La presa di coscienza dell'esistenza di questo complesso d'inferiorità, potrebbe risultare molto benefica, non solo per un migliore uso della nostra lingua.Hai trovato utile questo commento?SI NO | Segnala come inappropriato