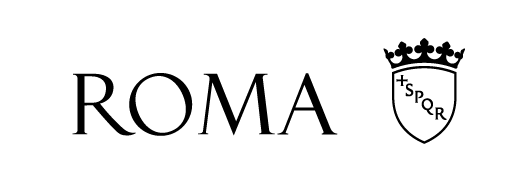Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
- Commenti
Se vuoi inserire un commento a questo documento o indicare con un voto da 1 a 5 la tua preferenza inserisci il tuo codice utente e la tua password dal pulsante Accedi in alto a destra.
Non sei ancora un nostro iscritto? REGISTRATI ON-LINE!!
Non sei ancora un nostro iscritto? REGISTRATI ON-LINE!!
-
17 / 17 utenti hanno trovato utile questo commento09/04/2025
"Primavera dintorno brilla nell' aria, e per li campi esulta, sì ch'a mirarla intenerisce il core"
Espressione della straordinaria sensibilità e dell'impareggiabile cultura di Giacomo Leopardi, la raccolta è costituita da liriche che traggono ispirazione dall'intima soggettività dell'autore sia quando trattano temi autobiografici sia quando affrontano argomenti filosofici o civili. Infatti, come si evince dall'edizione postuma del 1845, i componimenti sono di vario genere in base al contenuto, allo stile e alla metrica: canzoni, elegie, epistole in versi, idilli, ecc. L'essenziale presentazione che segue è da considerarsi, pertanto, puramente introduttiva e propedeutica ad ulteriori e necessari approfondimenti. Seguiamo l'ordine: nelle Canzoni All'Italia, Ad Angelo Mai, Sopra il monumento di Dante... (1818-'21) dall'impianto classicistico e dal linguaggio aulico, Leopardi affronta tematiche civili con spirito pessimista e polemico nei confronti della società del suo tempo, considerata inerte e corrotta e per questo contrapposta all'età antica, generosa e magnanima. Nel Bruto minore e nell'Ultimo canto di Saffo il poeta elabora inoltre, attraverso i due personaggi suicidi, l'idea di titanismo eroico come ribellione all'infelicità umana. Gli Idilli del 1819-'21, del tutto originali rispetto alla tradizione bucolica classica greca e latina, esprimono i sentimenti, le percezioni, la vita interiore dell'autore con un linguaggio semplice e quasi colloquiale. Esempi celeberrimi del "romanticismo" leopardiano sono: L'infinito, il cui scenario rappresenta lo spunto per una meditazione alimentata dall'immaginazione e dalle sensazioni (secondo la teoria del "vago e indefinito"); La sera del dì di festa, che inizia con la descrizione di un paesaggio notturno per poi soffermarsi sull'infelicità del poeta e sul ruolo inesorabile del tempo e Alla luna, incentrata sul tema della "ricordanza", condizione atta a trasfigurare il reale. Segue un periodo di "silenzio poetico" durante il quale Leopardi si dedica a studi filosofici tra l'altro superando il pessimismo storico nonché il titanismo eroico ed elaborando invece un sistema fondato su un pessimismo assoluto ossia cosmico. Negli anni 1828-'30, serenamente trascorsi in parte a Pisa poi a Recanati, il poeta compone i cosiddetti Grandi Idilli che corrispondono ad un rinnovamento delle sue capacità di immaginare e di commuoversi. A Silvia, Le ricordanze, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, il Canto notturno di un pastore errante dell'Asia e Il passero solitario riprendono dai precedenti idilli sia alcuni temi, come le illusioni, le speranze oppure le amene descrizioni paesaggistiche, sia lo stile delicato; tuttavia al di là degli apparenti collegamenti, del "caro immaginar", delle evocazioni della memoria e dei quadretti sereni, emerge in questi rinomati canti anche un'acquisita consapevolezza del "vero", della sofferenza e del vuoto dell'esistenza, espressa con toni misurati dalla razionalità ma, comunque, pieni di disillusione. Tra l'altro la maturità artistica del poeta si riscontra anche nell'ampia libertà metrica. Tra il 1831 e il '35, in coincidenza con il definitivo allontanamento da Recanati, Leopardi compone il cosiddetto Ciclo di Aspasia formato da cinque poesie, tra cui Amore e morte e A sé stesso, che traggono origine dalla forte delusione amorosa nei confronti della nobildonna fiorentina F. Targioni Tozzetti e che, perciò, presentano temi e linguaggio aspri ed antiidillici. Soprattutto quest'ultimo periodo si caratterizza per la notevole polemica contro l'ottimismo progressista, le ideologie spiritualiste e neocattoliche della Restaurazione. Nel poemetto finale La ginestra, composto presso Torre del Greco nel 1836, l'autore rivolge infatti impietose critiche socioculturali al suo "secol superbo e sciocco"; tuttavia individua la possibile soluzione in un auspicabile progresso civile ("verace saper, l'onesto e il retto conversar cittadino, e giustizia e pietade") fondato su una dignitosa solidarietà umana, indispensabile per contrastare la vera nemica: la natura.Hai trovato utile questo commento?SI NO | Segnala come inappropriato