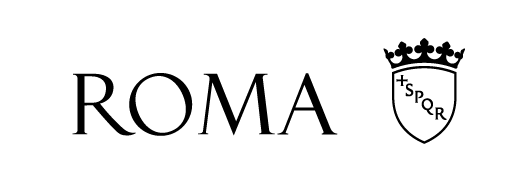Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
- Commenti
Se vuoi inserire un commento a questo documento o indicare con un voto da 1 a 5 la tua preferenza inserisci il tuo codice utente e la tua password dal pulsante Accedi in alto a destra.
Non sei ancora un nostro iscritto? REGISTRATI ON-LINE!!
Non sei ancora un nostro iscritto? REGISTRATI ON-LINE!!
-
5 / 6 utenti hanno trovato utile questo commento27/02/2023
«Davanti al tribunale della Storia»
Difficile condensare nello spazio a disposizione un commento su quest’opera: chi volesse può leggere la versione integrale sulla mia pagina FB “Daniela Carletti La sconfitta del tempo”. La Yourcenar (Y) dice «Ci sono libri che non si dovrebbero osare se non dopo i quarant’anni». Lo stesso vale per il lettore, quando la somma delle esperienze fa la differenza in termini di comprensione. “Mémoires d’Hadrien” è un capolavoro di “prosa poetica” in cui si fondono realtà e immaginazione plausibile, costruite sulla base di fonti e documenti. Citando Flaubert, la Y spiega «“Quando gli dei non c’erano più e Cristo non ancora, tra Cicerone e Marco Aurelio c’è stato un momento unico in cui è esistito l’uomo, solo”, avrei trascorso una gran parte della mia vita a cercare di definire, e poi descrivere, quest’uomo solo e, d’altro canto, legato a tutto». La Y sceglie la forma epistolare: neanche il diario sarebbe stato adatto, poiché un imperatore deve sottoporsi al responso dei suoi giudici: Marco Aurelio (a cui la lettera è rivolta), e la Storia incarnata nell’ecclesia dei lettori; ogni capitolo infatti, è costruito sui dettami della retorica che in greco è “l’arte del parlare in pubblico”. Risolto il problema formale, Adriano (A) può riprendere vita per esprimere la sua gravitas, senza svincolarla dall’uomo di cui apprendiamo passioni, ma anche debolezze che la Y non disdegna di illustrarci: A che spera nella morte di Lucio dopo averlo adottato, a causa della malattia di lui; A che seda nel sangue le rivolte dei popoli che non vogliono sottostare al giogo di Roma. “Memorie di Adriano” è «la meditazione scritta di un malato che dà udienza ai ricordi»; è il punto di vista di un uomo libero «Volevo trovare la cerniera ove la nostra volontà si articola al destino»; è la confessione del suo rapporto con Antinoo, svelato nelle parole del governatore Arriano; qui la Y dà il meglio di sé chiamando in causa l’unico altro personaggio che, in tutta l’opera si esprime in 1.a persona: sarebbe stata una caduta di stile far parlare A, di nuovo posto sul banco degli imputati di fronte ai posteri. Arriano in una lettera al suo imperatore scrive «Achille mi sembra il più grande degli uomini…E nulla in lui mi pare più grande della disperazione che gli fece disprezzare la vita e agognare la morte quand’ebbe perduto il suo diletto (Patroclo, ndr)»; A commenta «Arriano mi schiude il profondo empireo degli eroi e degli amici: non me ne giudica indegno». Da questa lettera inizia un crescendo finale straziante: A si accomiata dal mondo come imperatore consegnandoci due lasciti visionari, sulla nascita del potere della Chiesa e sul «filosofo dal cuore puro» Marco Aurelio; si congeda anche come uomo, raccontandoci la rinuncia al suicidio, poiché ad un imperatore è consentito togliersi la vita, unicamente per ragioni di Stato. Il finale in cui “cerca di entrare nella morte ad occhi aperti” come recita un verso della sua poesia più famosa, è struggente. Le ultime cinque righe sono proprio quella poesia “Animula vagula blandula” (Piccola anima smarrita e soave), che rimane per i posteri impressa nel marmo a Castel Sant’Angelo (il Mausoleo di A) e che, anche secondo la Y data la posizione in cui la colloca, diversamente dalla vox populi è da attribuirsi all’anima di A nel momento del trapasso. Se infatti fosse rivolta ad Antinoo, l’iscrizione marmorea sarebbe stata posta nel suo santuario: del resto prima del 1951, nessuno l’avrebbe interpretata diversamente. L’epigrafe che conclude l’ultimo capitolo, trasforma l’opera in un tributo ad A. Se dunque il libro racconta le sue memorie (impeccabile la traduzione dal francese), l’opera della scrittrice è un memoriale dedicato al Divino Adriano Augusto.Hai trovato utile questo commento?SI NO | Segnala come inappropriato -
3 / 4 utenti hanno trovato utile questo commento17/03/2022
Da leggere
Quanta e quale bellezza in quest'opera della Yourcenar, in quest'imperatore Adriano così umano, così saggio. Sotto forma di una lunga lettera a Marco Aurelio, Adriano si racconta; la sua vita, le sue ambizioni di pace, la sua passione per la civiltà greca, il suo amore per Antinoo. Lettura meravigliosaHai trovato utile questo commento?SI NO | Segnala come inappropriato -
5 / 6 utenti hanno trovato utile questo commento15/02/2022Roma vista dagli occhi di Adriano, attraverso la sua sensibilitá, la sua profonditá d'animo, la sua eccellenza. La contraddizione di sentirsi invincibili e umani allo stesso tempo, la presa di coscienza della caducitá dell'uomo tanto quanto del mito di Roma. Infondo Adriano non é altro che un uomo che finisce con il porsi quegli stessi quesiti sul senso della vita che prima o poi sfiorano ognuno di noi, e da cui se siamo fortunati possono derivare slanci poetici eccezionali.Hai trovato utile questo commento?
SI NO | Segnala come inappropriato -
43 / 43 utenti hanno trovato utile questo commento26/09/2020
"Animula vagula, blandula, hospes comesque corporis, quae nunc abibis in loca pallidula, rigida,
nudula" … P. Aelius Hadrianus, Imp. ( "Piccola anima smarrita e soave, compagna e ospite del corpo, ora t'appresti a scendere in luoghi incolori, ardui e spogli" … trad. di L. Storoni Mazzolani ). M. Yourcenar, studiosa di letteratura e storia antica, immagina che Adriano, imperatore romano del secondo secolo d.C., ormai ultrasessantenne, scriva una lunga lettera - interpretabile come un testamento spirituale per i posteri - destinata ufficialmente a Marco Aurelio, nipote adottivo nonché futuro imperatore dopo Antonino Pio, al fine di ripercorrere con nostalgia ma nel contempo con animo sereno ed appagato, le fasi principali della sua vita eccezionale, degna per questo di essere tramandata. Sentendosi inesorabilmente vicino alla fine della sua vicenda umana a causa di un'incurabile e progressiva malattia, sostenuto comunque da acuta saggezza, acquisita grazie alle complesse esperienze ma raggiunta anche attraverso gli assidui studi filosofici, animato dalla volontà di lasciare veridica testimonianza, il Princeps rievoca lucidamente, talvolta con compiaciuto spirito autocelebrativo, la giovinezza, la formazione, i numerosi viaggi ( svolti non solo per esigenze amministrative ma anche per amore della conoscenza ), la permanenza ad Atene e, naturalmente, le altre tappe fondamentali della sua gloriosa attività politica e militare, consapevole di aver contribuito, senza mai insuperbirsi ma anzi con senso del dovere e all'insegna di alti ideali, il pacifismo e la tolleranza in primis, alla grandezza e alla diffusione della civiltà di Roma. Nella tessitura della sua biografia ricorda, tra l'altro, che aveva preferito non solo rinunciare alle guerre di conquista ma anche abbandonare alcuni territori precedentemente annessi poiché aveva scelto, invece, di consolidare le posizioni già raggiunte, proteggendo perciò le frontiere ( ad esempio, in Britannia, realizzando il Vallum Hadriani ), migliorando le condizioni delle province e riducendo il divario sociale tra le diverse realtà dell'Impero. Il celeberrimo successore di Traiano nel corso della narrazione inserisce anche opportuni riferimenti ai suoi numerosi interessi intellettuali: rievoca la passione per la musica, per la poesia e soprattutto per l'arte, sia greca che romana, convinto fautore, specialmente in qualità di architetto, di una necessaria ed organica integrazione tra diversi stili e culture. La sontuosa Villa Adriana a Tivoli ( presso l'Urbe ), espressione dell'intimo ed articolato senso estetico dell'imperatore, rappresenta infatti una perfetta sintesi di elementi architettonici romani, ellenistici e orientali, i cui resti imponenti ci offrono ancora, seppure parzialmente, viva testimonianza della sua eclettica magnificenza. Le ricerche della scrittrice, basate sulla Historia Augusta, sulla Storia romana di Cassio Dione, sullo studio di siti archeologici etc., conferiscono pertanto scrupoloso realismo e scientificità alla ricostruzione dell'epoca e dei personaggi di questo saggio storico; d'altra parte, però, alcuni aspetti romanzati, dettati dalla libera interpretazione, finanche dalla fantasia della stessa Yourcenar, sondano gli aspetti umani, emotivi, affettivi del protagonista e apportano sfumature crepuscolari al lungo diario introspettivo. L'autrice francese, infatti, in quest'opera composita (del 1951) non ascrivibile ad un solo genere letterario, ci restituisce sia il politico equilibrato e lungimirante, dettagliatamente evidenziato nel contesto storico-sociale attraverso l'interazione continua fra giovinezza e vecchiaia, sia l'uomo raffinato, colto e versatile, contraddistinto da una complessa e tormentata personalità, da sentimenti profondi e laceranti che affiorano ad es. nel capitolo dedicato alla passione amorosa nei confronti di Antinoo; nel continuo gioco di trasparenze che permea i ricordi, gli aneddoti e le riflessioni personali non mancano, inoltre, amare disillusioni, delicati rimpianti o insanabili contraddizioni.Hai trovato utile questo commento?SI NO | Segnala come inappropriato