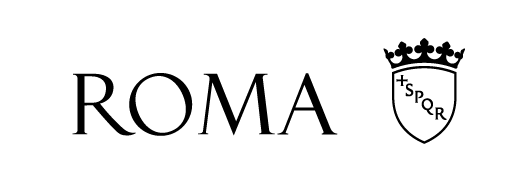giovedì
3
giugno
venerdì
21
maggio
giovedì
3
giugno
San Lorenzo mon amour
Rubrica sul territorio
Porta San Lorenzo
La porta, che dalla cinta muraria aureliana conduce all'interno dell’attuale quartiere San Lorenzo, ha conosciuto nel corso dei secoli ben tre denominazioni differenti: è chiamata Porta Tiburtina, perché attraverso questo passaggio si usciva dalla città, lungo la Tiburtina, asse viario di grande importanza, nato sul tracciato di una via usata nel passato per la transumanza tra la valle del Tevere e l'Appennino centrale. Lungo la strada consolare che conduceva all’antica Tibur (Tivoli), nel periodo repubblicano e imperiale venivano trasportati i prodotti agricoli e il travertino, materiale ampiamente impiegato nell’edilizia monumentale di Roma. Nell’alto Medioevo il nome della porta, come avvenne per molti accessi alla città, fu cristianizzato e prese il nome di Porta San Lorenzo, perché attraverso la via Tiburtina si arrivava alla Basilica costantiniana, sorta nel IV secolo d.C. vicino alla tomba del martire Lorenzo. I pellegrini, che si recavano presso la Basilica del santo, conoscevano questo passaggio anche come Porta Taurina o Capo di Bove, soprannome nato da due particolari elementi decorativi scolpiti sul travertino dell’arco augusteo: sul lato dell’ingresso alla città è presente un bucranio (un cranio di bue), mentre sul lato di uscita è scolpito un bucefalo (una testa di bue). Nella guida in volgare duecentesco “Le Miracole de Roma” si racconta che questo passaggio fosse conosciuto come “porta Taurina, perché vi sono scolpite due teste di bue, una scarnificata e una pasciuta; quella scarnificata si trova fuori ed è il simbolo di coloro che magri entravano a Roma; quella pasciuta si trova all’interno e rappresenta coloro che uscivano ingrassati da Roma; e questa porta Taurina è detta porta San Lorenzo o Tiburtina” (cfr. Ernesto Monaci, Le Miracole de Roma, Archivio della Società Romana di Storia Patria, 1915, p. 582).
L’arco augusteo in travertino, che oggi è visibile sul lato interno della porta, ad un livello stradale più basso, fu realizzato nel 5 a.C., per consentire il passaggio sopra la via Tiburtina di tre acquedotti: Aqua Marcia, Aqua Tepula e Aqua Iulia. Sul lato interno dell’arco sono presenti tre iscrizioni: la prima, in corrispondenza del canale della Aqua Iulia, risale all’anno di costruzione dell’arco e celebra i lavori di Augusto; sulla conduttura dell'Aqua Tepula, al centro, si trova l'iscrizione relativa al restauro di Caracalla del 212 d.C.; più in basso, l'iscrizione sul canale dell'Aqua Marcia ricorda il restauro eseguito sotto da Tito nel 79 d.C.
Tra il 270 e 275 d.C., durante la costruzione delle Mura Aureliane, l’arco subì un importante cambiamento. Fu inglobato nelle mura e trasformato, con l’aggiunta di due torrioni laterali, in uno dei nuovi accessi della città. La porta sorgeva poco prima del punto in cui si biforcavano la via Tiburtina e la via Collatina, similmente a quanto avveniva con Porta Maggiore, anch’essa costruita per il passaggio delle acque nella zona di biforcazione tra Prenestina e Labicana. Sotto l’imperatore Onorio, all’inizio del 400, furono eseguiti ulteriori interventi di rinforzo, testimoniati da un’iscrizione presente sul lato esterno della porta, dove fu aggiunta una controporta con cinque finestre che si aprono sull’ambiente interno, da cui veniva guidata la sarcinesca di chiusura (la controporta del lato interno fu invece rimossa nell'Ottocento). L’aspetto architettonico attuale, romano-repubblicano all'interno e tardoantico all’ esterno, risale quindi a questo periodo. Sembra che allo stesso periodo risalga anche la trasformazione delle torri laterali che furono inglobate in strutture quadrangolari. La porta fu rimaneggiata uletoriormente nel corso dei secoli, fino al 1917 quando fu chiusa al transito e trasformata nell’attuale area archeologica.
Dandovi appuntamento tra due venerdì per il prossimo approfondimento, vi invitiamo a sfogliare la nostra selezione di libri e risorse sul quartiere disponibili nelle Biblioteche di Roma, cliccando QUI.