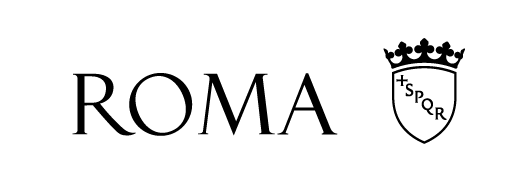martedì
27
luglio
martedì
6
ottobre
martedì
27
luglio
Invito all'autore
Tra le righe... vita e opere
Quale legame intercorre tra la vita di uno scrittore e i suoi romanzi? Tra la propria esperienza storica, umana, e quella dei suoi personaggi? Quanto in definitiva c’è di autobiografico nella sua opera? Non di rado capita che simili domande ci frullino nella testa mentre siamo intenti a leggere i romanzi di alcuni autori la cui stessa vita per certi versi potrebbe costituire materia per un’opera letteraria.
Il martedì, ogni 15 giorni a partire dal 6 ottobre, sulle pagine FB e Instagram della Biblioteca Nelson Mandela viaggeremo attraverso l’intreccio tra biografia e bibliografia, guardando alla vita e alla produzione letteraria di alcuni scrittori contemporanei.Agota Kristof
Christopher e la sua specie si trasferisce in California, nel 1939, ed è qui che entra per la prima volta in Ivar Avenue 1946 dove conosce l’induismo di Swami Prabhavananda, Il mio guru, su suggerimento del quale scrive la storia di Ramakrishna e i suoi discepoli.
Segue un breve periodo a Filadelfia, dove riprende ad insegnare inglese (come l’«Herr Isservut» degli anni Berlinesi), ai profughi fuggiti dall’Europa.
Torna in California, dove osserva i suoi vicini figli del benessere americano impauriti da George, Un uomo solo, la cui omosessualità – «il signor Strunk» utilizza ben altre parole -, potrebbe essere affrontata, a dirla con «la signora Strunk», con «la tecnica dell’annientamento tramite dolcezza». Del resto si sa che «Alcuni casi, presi per tempo, possono reagire alla terapia».
Sempre in California, un Cristopher Isherwood tanto personaggio quanto reale, proprio mentre «il giornale del mattino» annuncia che Goebbels “esorta” il popolo tedesco a votare «sì o sì», riceve la chiamata di Bergmann che lo invita a scrivere la sceneggiatura di quella «macchina infernale» che, come ogni film, è La violetta del Prater, affrontata, come ha scritto Giorgio Manganelli, con «mani stilistiche incredibilmente affusolate».
https://www.bibliotechediroma.it/opac/page/list/christopher-isherwood/651649230333
Comincia col raccontare Quello che non ricordo più, tra terremoti predetti da maghe, manuali per crescere i figli, maestre fumatrici, bidelle che infarciscono panini «con la versione», caffè corretti all’anice e ... se «Tonno + gru = rettile», allora Mosca più balena quanto fa? Ci parla delle donne, Valeria Parrella. Di Vera che «il trentuno agosto» dopo essersi svegliata «ricordava ciò che aveva sognato», di Grazia che vorrebbe un figlio come Il premio per averne cresciuto un altro. Indaga la maternità. Lo spazio bianco che separa una madre dalla possibilità di abbracciare la propria bambina chiusa in un «acquario», quello spazio durante il quale si costruiscono «enormi impalcature di significato, per dieci minuti dopo farle crollare». Arriva quindi il Tempo di imparare, in cui si è proiettati in un mondo «su due sole dimensioni, come fosse sempre un disegno, una pagina», e una madre non può accettare, ma può solo sperare «Che ogni scala si appiani, scompaiano le discese e le salite che il passo non indovina». Di nuovo l’istinto di resistere, di proteggere il proprio figlio superando le barriere, trovando canali di comunicazione. È interprete della lingua dei segni, Parrella, e sa, come le sue madri, che la ricerca di nuovi canali di comunicazione è la vera posta in gioco. E comunicano, Almarina ed Elisabetta, nel carcere minorile di Nisida, due solitudini che diventano inseparabili; proprio in quel riformatorio in cui l’autrice, insieme ad altri scrittori, incontra regolarmente i ragazzi detenuti. Del resto: «se c'è un minore colpevole c'è un adulto colpevole».
https://www.bibliotechediroma.it/opac/page/list/valeria-parrella/651649230336
John Steinbeck
«No, Lennie. Non ce l’ho con te. Non ce l’ho mai avuta, e non ce l’ho ora. Voglio che tu lo sappia, Lennie.». Tradotto da Cesare Pavese nel 1938, Uomini e topi, la storia di due braccianti - George e Lennie - scritta per i braccianti, è ancora oggi uno dei romanzi più letti nelle scuole di lingua inglese di tutto il mondo. Nei dialoghi miseria, disperazione, ma anche rabbia. Quella stessa rabbia che l’anno dopo sulle facce «dure» e «ostinate» degli uomini diventa Furore (negli Stati Uniti esce nel ’39), quando le donne e i bambini capiscono «che non sarebbero crollati». Il Dust Bowl, il ’29, le code di disoccupati («Shelter line stretchin' round the corner», canta Springsteen), i viaggi verso il west - dove ambienterà La valle dell’Eden (l’edizione originale è del ’52) -, La battaglia per la sopravvivenza, vissuti e documentati da uno Steinbeck con l’umanità dello scrittore e la capacità documentaria del reporter. Professione, quest’ultima che lo porta in Unione Sovietica insieme al fotografo Robert Capa quando il mondo è già diviso in due blocchi (Diario russo), e poi nel Vietnam in guerra. Prima del Nobel, vinto nel 1962, con il suo ultimo romanzo ci conduce nell’intimità del negozio di alimentari e verdura in cui lavora Ethan, a Long Island, ovvero ne L’inverno del nostro scontento.
https://www.bibliotechediroma.it/opac/page/list/john-steinbeck/651647232494
https://www.bibliotechediroma.it/opac/resource/the-ghost-of-tom-joad-audioregistrazione/RMB0424817
Lalla Romano
«Simile a un fiore il cielo/dagli orli vermigli posa/lieve sulla terra oscura». La pittura - la sua prima esperienza artistica - si fa poesia in questi versi giovanili: Fiore è del 1941. Torino allora è sotto i bombardamenti e Lalla Romano si rifugia con il figlio a Cuneo, entra nel Partito d’azione e supporta le bande partigiane di Giustizia e Libertà (ambientazione in parte rievocata in Tetto murato edito nel ‘57). La sua opera poetica prosegue quando «i pingui soli d’autunno/rigurgitano come forzieri/ di gioie non possedute» (L’autunno esce nel ’55). Terminato il conflitto e abbandonata la pittura, si dedica alla raccolta di prose metaforiche Le Metamorfosi, libro di sogni («Mi trovo su di un treno che corre lungo un rettilineo, sopra un ponte gettato sul mare ad altezza vertiginosa»). Procedendo lungo il cammino dalla poesia alla prosa - come lei stessa definisce la sua opera – c’è Maria, o meglio «c’era già, Maria», era già lì «quando entrammo nella nostra casa», a cavallo tra due mondi e due culture (contadina e borghese), tra le quali il rapporto non può che essere di scambio reciproco. Il cammino prosegue ne La penombra che abbiamo attraversato (1964), quando, in seguito alla morte della madre, la scrittrice va alla ricerca dell’«aria» della sua infanzia, che riconosce «all’odore leggero che sa di latte, di strame, di erbe amare», cui segue Le parole tra noi leggere (1969), nel tentativo di recuperare la memoria dei rapporti con il figlio. In Lalla Romano vita e scrittura si intrecciano, dando luogo, per sua stessa ammissione, a quell’eccesso di autobiografismo che, paradossalmente, fa sì che la sua opera esuli addirittura dal genere autobiografico.
https://www.bibliotechediroma.it/opac/page/list/lalla-romano/651647232813
Donald E. Westlake/Richard Stark
«Vivere con un uomo è già abbastanza difficile; vivere con un gruppo può essere snervante. Io convivo da anni con il consorzio che si fa chiamare Don Westlake, e ancora non posso dire con certezza, quando mi alzo al mattino, con chi della congrega prenderò il caffè». Così dichiara la moglie di Donald Edmund Westlake, autore di culto del poliziesco americano, nato a Brooklyn il 12 luglio del 1933 e morto in Messico nel 2008.
Lo scrittore, nel corso della sua lunga carriera, ha infatti adottato numerosi pseudonimi, dando vita a personalità letterarie contrastanti. Il suo personaggio più celebre è Dortmunder, un ladro sgangherato, il cui nome, contrazione di "don't murder", è una dichiarazione di intenti: si tratta infatti di esilaranti commedie nere incentrate su truffe e rapine in cui il maldestro ladro non fa mai fuori nessuno. Siamo dalle parti dell'hitchcockiana Congiura degli innocenti, e la scrittura di Westlake, umoristica e surreale, tiene il lettore incollato alla pagina.
L'altro lato della medaglia si chiama invece Richard Stark. «Quando squillò il telefono, Parker era in garage ad ammazzare un uomo», recita l'incipit secco e feroce di Terra bruciata, e ci presenta in poche frasi un rapinatore freddo e spietato che parla poco e uccide all'occorrenza. La prima avventura di Parker si intitola Payback - Anonima carogne e narra delle vicissitudini del protagonista che, tradito dai compagni e dalla sua donna, deve vendicarsi e riconquistare il bottino.
Le storie di Parker sono state adattate con successo sullo schermo, e il rapinatore dagli occhi di ghiaccio è stato impersonato da Lee Marvin, Mel Gibson e Jason Statham. «Se volete conoscere il noir, cominciate da Stark» dichiara Stephen King, e nella Metà oscura omaggia l'autore, narrando dello scrittore Thad Beaumont il cui violento alter ego letterario George «Stark» acquista malauguratamente vita propria.
Parker e Dortmunder paiono due personaggi opposti, ma ciò che li accomuna è un'ironia furi dal comune, elemento che in genere latita nel poliziesco classico. Purtroppo tali romanzi non sono più stati ristampati, ma potete trovarli in biblioteca e sarete felici della scoperta.
https://www.bibliotechediroma.it/opac/page/list/westlake-stark/651650235595
Helga Schneider (Io, piccola ospite del Führer) nell’inverno del 1944 è ospite nel bunker di Hitler. È la zia, collaboratrice del ministro Joseph Goebbels, a promuovere l’incontro: «non l’avevo mai sentita esprimere una critica sull’operato di Hitler».
Helga Schneider, tre anni prima, era stata abbandona dalla madre che aveva preferito servire il Führer arruolandosi nelle SS e finendo a «legare le prigioniere ai tavoloni» nei campi di concentramento di Ravensbrück e di Auschwitz-Birkenau.
Helga Schneider trascorre l’infanzia ne Il rogo Berlino dove ci sono «finestre senza infissi, senza gente che guarda fuori per vedere sorgere o tramontare il sole». Dove si vive Per un pugno di cioccolata ed altri specchi rotti.
Helga Schneider incontra per la prima volta la madre nel’71: «E non eri pentita, anzi. Ancora ti compiacevi del tuo passato, del tuo essere stata, di quell’efficiente fabbrica di orrori, una impiegata modello».
Helga Schneider incontra la madre una seconda volta (Lasciami andare, madre):«Dopo ventisette anni oggi ti rivedo, madre, e mi domando se nel frattempo tu abbia capito quanto male hai fatto ai tuoi figli»
Helga Schneider. La testimonianza che scaturisce dalla fusione tra la sua vita e la sua opera è completa e unica. Completa, perché l’autrice non ha mai smesso di indagare a tutto campo i crimini nazisti, a cominciare da quando Il piccolo Adolf non aveva le ciglia. Unica, perché la bambina Helga ha subito profondamente gli effetti di un’ideologia che è riuscita a recidere tutti quei legami che non fossero funzionali ai progetti hitleriani. Proprio tutti: «Dopotutto sei mia madre. Ma impossibile dire: amore. Non posso amarti, madre».
Link al BiblioTu: https://www.bibliotechediroma.it/opac/page/list/helga-schneider/651652234451
Jim Thompson
«Un'erbaccia è una pianta che non è al suo posto» scrive Jim Thompson in un romanzo, e l'affermazione è perfetta pure per lui, che visse e morì da outsider, come i suoi personaggi. L'autore nasce in Oklahoma nel 1906 e si sostenta con i lavori più improbabili e ai margini della legge, dal trivellatore di pozzi al contrabbandiere, finché a più di quarant'anni approda alla carriera letteraria.
Lo si potrebbe definire il Dostoevskij del crimine in quanto i suoi noir mettono a nudo lo stato di vuoto esistenziale dei personaggi, incompresi dalla società.
Thompson ha come riferimenti letterari Faulkner e Céline, ma anche il Capitale di Marx e l'Edipo re, e le sue storie rivelano il lato oscuro celato dietro al Sogno Americano. I romanzi, definiti duri e scorretti, uscirono nel Giallo Mondadori solo parecchi anni più tardi. L'originalità di Thompson non sta tanto in ciò che racconta, ma nel come: molte storie sono narrate in prima persona da un protagonista che in apparenza è un tutore della legge ma che man mano mette a nudo la sua identità di folle criminale, mentre noi, spaesati, ci troviamo a vestire i suoi panni. Patrick Bateman, il celebre yuppie serial killer creato da Bret Easton Ellis, ma anche il Dexter dell'omonima serie tv, non sarebbero mai esistiti senza l'ambiguo Nick Corey di Colpo di spugna o il vicesceriffo psicopatico Lou Ford.
«Tutti noi che iniziammo la partita con le carte truccate, che volevamo tanto e abbiamo avuto così poco, che eravamo pieni di buone intenzioni e abbiamo agito tanto male» si autodefinisce Lou nello spiazzante finale dell'Assassino che è in me. Kubrick restò colpito dal suo genio e gli affidò la sceneggiatura di Rapina a mano armata e di Orizzonti di gloria, mentre il crudele e romantico Getaway di Peckinpah è tratto dal suo omonimo romanzo, così come lo spietato Colpo di spugna di Tavernier e Rischiose abitudini di Frears.
Poco prima della fine (Hollywood, 1977), bruciato dall'alcool e amfetamine, e dimenticato da tutti, Thompson dichiarerà alla moglie: «Abbi solo pazienza. Dieci anni dopo che sarò morto, diventerò famoso».
Herta Müller
Nel Banato Rumeno, in un villaggio di lingua tedesca, nasce nel 1953 Herta Müller. Dopo gli studi di letteratura lavora come traduttrice, ma una mattina i suoi «grossi dizionari» sono lì, «per terra in corridoio, vicino alla porta dell’ufficio»: si è rifiutata di diventare un’informatrice dei servizi segreti comunisti rumeni e deve lasciare l’impiego. «Io scrissi in piedi quel che lui mi dettava», ad un certo punto «arrivò la terribile parola: colaborez, che collaboravo». Da allora in poi fu perseguitata. Ed è della dittatura che racconta. Ne Il paese delle prugne verdi non dimenticate mai di mettere «un capello nella lettera»: se quando arriva a destinazione il capello «dentro non c’è», allora «vuol dire che è stata aperta». Esordì con Bassure, raccolta di racconti del 1982, dove è una bambina a parlare: in una foto «era grande la metà della sedia a cui si teneva stretto con la mano», in un’altra «stava ritto come un palo davanti a una staccionata», «in tutte le fotografie papà era pietrificato in un gesto. In tutte le fotografie papà sembrava non saper più cosa fare. Ma lo sapeva sempre». Anche quando si era arruolato nelle SS. Nel 1987, è costretta ad esulare dopo aver criticato la dittatura rumena e si trasferisce –In viaggio su una gamba sola- a Berlino. Quando vince il Nobel per la Letteratura, il primo ricordo è alla madre, appartenente alla minoranza rumena di lingua tedesca deportata nei campi di lavoro sovietici. Esperienza che Herta Müller racconta con gli occhi di Leo, ovvero il poeta Oskar Pastior, con cui avrebbe dovuto scrivere L’altalena del respiro, sulla quale, dopo la morte del poeta, l’autrice decide di salire da sola, sempre accompagnata da quella domanda che non nascondeva altro che amore: «Ce l’hai un fazzoletto?».
Speciale 8 marzo: Shirley Jackson
«Adesso che la casa si è impadronita di noi, forse non ci lascerà più andare» narra Shirley Jackson nella Casa degli invasati, e mette in luce quello che per lei è il focolare domestico, fin da bambina luogo di gioia e insieme di tormento. L'autrice, nata a San Francisco nel 1916, ebbe un'adolescenza tormentata per via di una madre svalutante e di una grave depressione che a vent'anni la costrinse a lasciare gli studi. Si sposò con un intellettuale ebreo e simpatizzante comunista da cui ebbe tre figli, ma che non fu mai ben visto dalla famiglia conservatrice. Interessata da sempre a pratiche medianiche ed esoteriche, oltre che grande amante dei gatti (ne aveva sei, tutti neri), la Jackson amava definirsi un po' “strega”. Nel giugno del 1948 esce sul New Yorker il racconto La lotteria, provocando reazioni incontrollate, simili a quelle che suscitò Orson Welles con La Guerra dei mondi. La storia narra di una lotteria che si tiene ogni anno in un paesino del New England, ed è una denuncia alla società e ai suoi rituali. Le opere della Jackson erano molto avanti per l'epoca e oggi hanno ispirato diversi film e una celebre serie tv (The Haunting of Hill House); in Italia l'autrice fu scoperta da Fruttero & Lucentini e da loro pubblicata nel 1963 insieme a Kerouac, Capote e alla O'Connor nella storica antologia La verità sul caso Smith. La Jackson ha il dono di narrare il soprannaturale e l'incubo come metafora del reale, un reale che a lei stava stretto, a partire dall'infanzia infelice fino al difficile matrimonio con un uomo che si rivelò infedele e maschilista. L'autrice morì nel 1965, a soli 48 anni, a causa di amfetamine e barbiturici, ma ci restano le sue opere, perché la vera stregoneria che lei praticava era la scrittura, da lei stessa definita un incantesimo per tenere a bada la realtà, e con il quale ancora oggi continua ad ammaliarci.
Speciale 8 marzo: Simone De Beauvoir
«Se io voglio definirmi sono obbligata anzitutto a dichiarare: sono una donna[…]. Un uomo non comincia mai col classificarsi come un individuo di un certo sesso: che sia uomo, è sottinteso». È con Il secondo sesso (1949) – volume ritenuto scandaloso in Francia e messo all’Indice dal Vaticano -, che Simone de Beauvoir avvia la discussione sulla condizione femminile che caratterizzerà i decenni successivi.
Nel 1971 redige il “Manifeste des 343 salopes”, firmato da donne che si autodenunciano per aver fatto ricorso all’aborto: in Francia è ancora in vigore la legge del 1920 che punisce con il carcere chi adotti tale pratica. Sempre negli anni ‘70 Simone de Beauvoir presiede “la Lega dei diritti delle donne” preposta a vigilare su ogni atto discriminatorio nei confronti delle donne e a informarle dei loro diritti. La condizione di subordinazione della donna nei confronti dell’uomo, nel 1967 è analizzata attraverso le storie di Monique, di Murielle e della madre di Philippe, nel romanzo Una donna spezzata (da cui fu tratto l’omonimo sceneggiato RAI del 1989). È leggendo la sua opera autobiografica (Memorie di una ragazza per bene, L’età forte, La forza delle cose, Una morte dolcissima, La terza età, A conti fatti), che si può capire quanto la vita di Simone de Beauvoir sia tutt’uno con l’impegno culturale e politico (non solo femminista), e quanto vita e opera in lei siano fuse: «Il fatto è che sono una scrittrice: una donna scrittrice non è una donna di casa che scrive, ma qualcuno la cui intera esistenza è condizionata dallo scrivere». Un ultimo tassello della sua vita, inedito e recentemente pubblicato da Ponte alle Grazie, Le inseparabili*, consente, attraverso il racconto dell’amicizia con Elisabeth Lacoin, di intendere i prodromi della sua percezione della discriminazione di genere e del sessimo.
*Il libro non è ancora disponibile e, appena possibile, sarà inserito nel prossimo piano acquisti della biblioteca
Francisco Coloane
Francisco Coloane, il «mastro tuttofare», come lui stesso si definisce in Una vita alla fine del mondo, ha scritto da autodidatta senza mai «dipendere economicamente e psicologicamente dalla letteratura». Ha fatto di tutto nella vita, Coloane, mandriano, pastore, artigiano, marinaio, viaggiatore, e tutto, della vita, ha narrato: praterie sterminate, mari ghiacciati, cacciatori di balene e di foche, contrabbandieri, cercatori d’oro, cigni dal collo nero, fenicotteri, guanachi, bettole, cornamuse, chitarre, meschinità, imbroglio, solidarietà e amore. Nella sua opera è racchiuso tutto il sud del mondo: «La vita mi ha regalato un ricco patrimonio di esperienze con esseri viventi e cose, che non avrei immaginato neppure nella più rosea aspettativa dei sogni di un ragazzo che partì in cerca di qualcosa in più, verso l’estremo sud anziché verso il nord». Del resto, come lui stesso ha scritto, il suo lavoro letterario «non è stato altro che lo sforzo di trasmettere la realtà di quelle regioni australi, che la creatività dell’immaginazione è solita superare».
Leggendo i suoi romanzi e racconti potreste ritrovarvi a guardare attraverso le acque dell’oceano per cercare di scorgere il diavolo incatenato nel fondale di fronte a Capo Horn, a dover fuggire inseguiti da Julio Popper nella Terra del fuoco, a seguire La scia della balena, con I balenieri del Quintay nel mezzo di una tempesta nei pressi di Capo Tamar, o semplicemente in compagnia di specie animali uniche al mondo.
Francisco Coloane è stato lo scrittore che forse più di tutti ha influenzato Luis Sepúlveda. Di quest’ultimo si ricorda la scomparsa, un anno fa.
Lucia Extebarrìa
Ci sono le donne. Rosa e Ana di Amore, Prozac e altre curiosità, Beatriz e i corpi celesti, Maria, Raquel, Elsa e Susi di Noi non siamo come le altre, Olga, Valeria e Sabina di Il vero è un momento del falso, e tante, tantissime altre. Narra di donne e di destini femminili, Lucía Etxebarría. Donne manager, modelle o aspiranti tali, ragazze anoressiche, ragazze madri, donne che hanno difficoltà ad uscire da Una storia d’amore come tante, donne che non riescono a superare i propri traumi. Storie di tossicodipendenza, storie di chi è costretta ad abbandonare la propria famiglia, il proprio lavoro e a ricominciare tutto da capo.
E ci sono gli stereotipi femminili – del cinema, della televisione, dei media – ai quali donne, e anche uomini, cercano a tutti i costi di assomigliare: vestendo, parlando, vivendo le relazioni umane, anche e soprattutto quelle sentimentali, secondo modelli preordinati.
A tutte le donne, e gli uomini, Lucía Etxebarría ricorda che non è l’immagine a contare ma l’indipendenza critica. Ed è la condivisione vera e sincera delle vite degli altri, l’unica cosa che può salvarci da tutto questo: sono i sapori e i colori che si fondono, sono gli artisti, gli intellettuali, gli immigrati, i poveri, i bambini della ludoteca, le donne del centro di autoaiuto del quartiere madrileno di Lavapiés – piccola realtà in una città in cui la norma è disinteressarsi delle vite degli altri – che pur non senza contraddizioni, tentano di dare e darsi una speranza.
Zadie Smith
«VIETATO IL POSTEGGIO DI QUALUNQUE VEICOLO IN QUALUNQUE GIORNO». Fu grazie a questo cartello che la vita di Archie Jones fu salva. Egli giaceva «come un angelo caduto; nei pugni stringeva le medaglie dell’esercito (a sinistra) e la licenza matrimoniale (a destra), perché aveva stabilito di portare i suoi errori con sé». Ma per sua fortuna Mo, l’ammazza piccioni, aspettava la consegna di un carico di carne, e Mo era decisamente intransigente sul fatto che «Nessuno si gassa» sulla «sua proprietà». È Denti bianchi il primo libro best seller di Zadie Smith, a proposito del quale fu coniata l’espressione realismo isterico ad indicare il romanzo che persegue insistentemente la vitalità. Ed è in questa prima opera che è racchiuso gran parte del mondo dell’autrice: confronto e scontro culturale, generazionale, crisi di identità. Seguiranno poi altri romanzi ambientati per lo più a Londra (Smith nasce a Brent, quartiere nord-ovest della città abitato da operai): del 2002 è L’uomo autografo (Alex, 27 anni, commercia autografi di persone famose), del 2005 è On beauty (i Belsey e i Kipps, in perenne contesa accademica e non solo), del 2012 NW ambientato a Kilburn dove l’occhio è facile che cada su «poltrone» e «strisce di moquette buttate via, giacigli stradali per gli ubriaconi del quartiere, le sale giochi, i mestoli unti e i minitaxi … tutti coperti di merda». Romanziera ma anche saggista, Zadie Smith, è chiara nel dirci Perché scrivere: «Scrivere ci permette di dimostrare che possediamo abilità, idee e mezzi di comunicazione che sono nostri e basta, non legati alle carte di credito o alla posizione sociale».
Joyce Carol Oates
«Il nostro nemico è per tradizione il nostro salvatore, perché c'impedisce di essere superficiali» scrive Joyce Carol Oates, narratrice del lato oscuro e violento del sogno americano. L'autrice, nata nel 1938 nello stato di New York, utilizza spesso la formula del thriller psicologico, ma anche del romanzo gotico e della fiaba dark con uno stile personale e coinvolgente molto vicino al flusso di coscienza. Acqua nera narra in prima persona le ultime ore di vita della segretaria di Ted Kennedy che morì in una palude in circostanze misteriose; Ragazze cattive di un gruppo di adolescenti ribelli che in un paesino degli anni Cinquanta creano una banda per difendersi dai soprusi maschili. La tematica della violenza di genere è presente nel celebre racconto Dove stai andando, dove sei stato?, in cui un'adolescente in cerca del principe azzurro si fa ammaliare sulla porta di casa da un misterioso ragazzo dagli intenti oscuri. «La lettura è l'unico mezzo con cui scivoliamo involontariamente, spesso ineluttabilmente, nella pelle, nella voce e nell'anima di un altro» dichiara l'autrice, ed è quello che ci accade nel leggere Blonde, la pseudobiografia di Marilyn Monroe, un romanzo di finzione che descrive in modo provocatorio e poetico il dramma dell'attrice «il cui problema non era di essere bionda e svampita, ma di non essere né bionda né svampita.» La Oates ha all'attivo quasi 60 romanzi e oltre 700 racconti e il suo eclettismo le ha permesso di cimentarsi in opere svariate, tra cui il saggio Sulla boxe che ripercorre la storia di tale sport dai combattimenti tra schiavi fino a leggende come Muhammad Ali e Myke Tyson, perché «la vita è come la boxe in molti particolari inquietanti. Ma la boxe è soltanto come la boxe.»
Qualsiasi libro a cui ci accostiamo di tale autrice, non può non affascinarci.
Sándor Marái
La vita di Sándor Marái e le vicende europee (Confessioni di un borghese e Volevo tacere) sono inscindibili. Leggendo il racconto di quegli anni – tra il 1900 e il 1948 – si assiste alla decadenza progressiva di quei valori cui il giovane scrittore era stato formato. A trentaquattro anni (nel 1934), è già in grado di inquadrare in poche righe (monito per ogni generazione futura) un’intera epoca: «Gli ideali in cui mi hanno insegnato a credere sono diventati anticaglie arrugginite da gettare nella spazzatura; l’istinto del gregge ha imposto il suo regime di terrore a territori immensi che un tempo facevano parte del mondo civile. La società in cui vivo è diventata indifferente non soltanto ai massimi valori dello spirito, ma anche allo stile umano e intellettuale della vita civile». Ed è proprio la sua vita, fatta anche di vagabondaggi, privazioni, povertà, censure ed esilio, che consentirà allo scrittore ungherese di raccontare con eccezionale acume e profondità i valori dello spirito e le grandi passioni umane. Dall’incontro tra due uomini il cui dialogo si consuma con la lentezza con cui ardono le braci in un castello ai piedi dell’Alsazia, ai giochi di un gruppo di ragazzi abbandonati a loro stessi a due passi dal fronte bellico nell’alta Ungheria; dalla vicenda di una ragazza e di suo padre durante l’assedio dei russi a Budapest, alla miseria e alla nobiltà d’animo di Napoli e dei napoletani. Nell’universo di Sándor Marái, fatto di diari, romanzi e poesia, si può accedere da una qualunque delle sue opere, purché si abbia voglia di trovarsi di fronte alla natura umana e alle sue contraddizioni.
James Baldwin
Scopre la passione per la scrittura intorno ai quattordici anni. Predicatore per tre anni in una chiesa di Harlem, poi impiegato nelle ferrovie del New Jersey, James Baldwin si trasferisce in seguito a Parigi e grazie ad una borsa di studio inizia a dedicarsi interamente alla scrittura. Lo fa scrivendo di argomenti, all’epoca, negli anni Cinquanta, ancora tabù come omosessualità, incontri tra etnie differenti, razzismo. All’inizio degli anni Sessanta fa ritorno negli Stati Uniti per partecipare al movimento per i diritti civili per gli afroamericani, legando la sua figura a quelle di Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King Jr. In Gridalo forte (1952) ci porta nella Harlem della sua adolescenza, al centro de La stanza di Giovanni (1956) ci sono le relazioni umane e il conflitto tra convenzioni sociali e libertà personale, in Se la strada potesse parlare (1974), che Barry Jenkins ha trasposto nell’omonimo film (2018), amore e ingiustizie sociali, in Un altro mondo (1962) è proprio a queste ultime che il protagonista finisce per arrendersi. Si può accedere al mondo di James Baldwin non solo attraverso i suoi romanzi, ma anche leggendo la sua produzione saggistica (Questo mondo non è più bianco, del 1955, e Congo Square del 1976, tra gli altri). La profonda riflessione di Baldwin sulla cultura e i costumi americani è ben rappresentata anche in I am not your negro (2017), documentario del regista Raoul Peck che cerca, esaminando gli scritti e i discorsi dello scrittore, nonché alcuni aspetti della sua biografia, di rintracciare nella cultura bianca americana le origini della difficoltà nel rapporto con l’altro.
Bret Easton Ellis
«Prima l'uomo prende un drink, poi il drink prende un drink, poi il drink prende l'uomo» scrive Bret Easton Ellis, ed è quasi una dichiarazione di poetica. I romanzi dell’autore, nato a Los Angeles nel 1964, sono la narrazione di un’America cupa e dannata che si cela dietro al mondo rutilante dell’apparenza. Durante gli anni del college, Ellis si iscrive a un corso di scrittura creativa e a 19 anni sforna la sua opera d’esordio, Meno di zero. Il romanzo è la storia della solitudine esistenziale di Clay, adolescente che vive nella patinata Hollywood degli studios anni '80 e tra party in piscina, musica new wave e cocaina registra l’horror vacui di una generazione che in apparenza ha tutto, ma non desidera più nulla. «Torbido ma non morboso» lo definisce Fernanda Pivano e la cruda ironia di Ellis, unita al suo stile invidiabile, diventa subito un caso letterario. Con Le Regole dell'attrazione (1987) l'autore ritrae il mondo dei ragazzi perduti utilizzando una tecnica narrativa ispirata ai videoclip. Il romanzo, stiloso e dall'incipit travolgente, conquista Roger Avary (coautore con Tarantino della sceneggiatura di Pulp Fiction) che nel 2002 ne trae un film. Nel 1991 Ellis pubblica American Psycho, la storia di Patrick Bateman, rampante yuppie newyorchese di giorno ed efferato serial killer di notte, e rivoluziona non solo il noir, ma la letteratura in generale. La soggettiva del protagonista, ugualmente ossessionato dagli abiti firmati, dai ristoranti lussuosi e dalle droghe più costose come dal sangue delle sue vittime, è una metafora non solo del lato buio dell'America anni '80, ma dell'ipocrisia della nostra società in toto. Nel 2000 Mary Harron ne trae un film efficacemente interpretato da Christian Bale. Tuttavia il modo migliore per apprezzare la follia e il sarcasmo di Patrick Bateman è leggere questo oscuro cult che è già un classico.