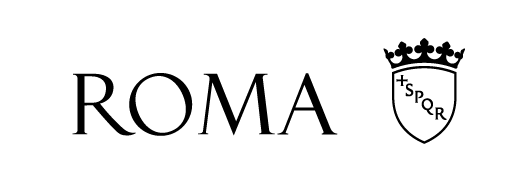mercoledì
5
maggio
giovedì
29
aprile
mercoledì
5
maggio
Fahrenheit 451
Visioni. L'altra faccia dei classici.
Disegni e testo di Tim Hamilton
Traduzione di Adalidia Lussonzer
Mondadori Oscar Ink, 2018
Nel 1953 negli Stati Uniti veniva pubblicato per la prima volta Fahrenheit 451, il romanzo più celebre di Ray Bradbury. Le inquietudini post-belliche e l’ansia dovuta allo shock nucleare fanno da sfondo ad una riflessione sul ruolo della memoria collettiva, dell’arte e della letteratura come strumenti di realizzazione dell’individuo. Il pericolo dell’affermazione di una visione unica, dell’affievolimento delle coscienze attraverso l’abitudine indotta a non pensare, il fine ultimo del controllo delle masse per il mantenimento dello status quo, rappresentano l’asse portante di un’opera che a distanza di quasi settant’anni mostra ancora tutta la sua attualità.
Montag fa il pompiere. Il suo lavoro, però, non consiste nello spegnere incendi, ma nell’appiccare roghi nelle case di quei sovversivi che ancora conservano libri. In una società in cui l’unica forma di intrattenimento è quella dei programmi televisivi trasmessi su schermi giganti, pervasivi, rassicuranti, un libro è un pericolo enorme, poiché costringe a pensare ed apre le porte al dubbio. L’adattamento a fumetti di Tim Hamilton, uscito in patria nel 2009 e arrivato in Italia nove anni più tardi, conserva sia il fascino della narrazione che la profondità della storia, restando sostanzialmente fedele all’opera originale. Dal punto di vista grafico l’autore si pone nella tradizione del fumetto americano, strizzando l’occhio al filone supereroistico. L’impostazione della tavola, pur mantenendo un’articolazione di base in tre strisce di due vignette ciascuna, è sempre dinamica, e lascia ampio spazio alle frequenti splash pages, ad un utilizzo drammatico delle inquadrature e ad una frequente scomparsa dello spazio bianco con le vignette che si innestano direttamente su un’immagine che è allo stesso tempo sfondo e narrazione.
La scelta cromatica è allo stesso modo funzionale alla costruzione dell’impianto narrativo, con l’utilizzo estensivo di tonalità spente intervallate da esplosioni violente di colore, così da graduare visivamente lo svolgimento della trama ed il crescendo delle emozioni.
Il ritmo è serrato, e la ricostruzione visiva aiuta a rendere più fluidi molti passaggi che nel testo originale potevano risultare eccessivamente lunghi, a tutto vantaggio della storia che è veicolata in maniera più immediata ed incisiva. Una capacità di sintesi propria degli adattamenti più riusciti, che apre la strada ad una riflessione ulteriore. Nel testo originale si fa riferimento ai classici illustrati ed ai fumetti che, al contrario dei libri, sopravvivono come forma accettata di produzione letteraria, simbolo di un declino che mira a comprimere la letteratura in un’espressione rapida, e per questo superficiale, di intrattenimento.
L’adattamento di Tim Hamilton, che nella sua essenza appartiene alla categoria, mostra significativamente questo passaggio in una tavola, generando così un gioco di specchi in cui, paradossalmente, l’opera critica se stessa. La scelta non è casuale, ed ha il valore di un manifesto: è la presa di coscienza di un mezzo espressivo capace di confrontarsi con la materia letteraria, di trasformarla, di giocare con quei preconcetti che, ancora pochi decenni fa, relegavano il fumetto in una dimensione di puro intrattenimento, capace di attrarre un pubblico di nicchia e, tutto sommato, da non prendere poi veramente sul serio.