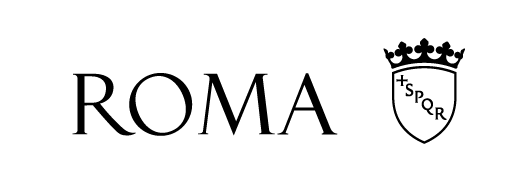giovedì
29
luglio
giovedì
8
ottobre
giovedì
29
luglio
È fuori catalogo? Lo troverai in biblioteca!
Tra le righe … dei classici che mancano da un po’
“Ma è un classico!", esclamiamo a volte quando, in libreria, ci sentiamo rispondere che il libro richiesto è fuori catalogo e non si ha notizia di nuove edizioni. La cosa ci sorprende, eppure è così: il nostro libro è introvabile, per cui, se è vero, come scriveva Italo Calvino, che «i classici sono quei libri di cui si sente dire di solito: "Sto rileggendo..." e mai "Sto leggendo..."», è altrettanto vero che molta letteratura “di formazione” è difficile leggerla anche solo per la prima volta, perché apparentemente irreperibile.
Mentre usciamo sconfortati dalla libreria, abbiamo rinunciato all’idea di leggere l’opera di cui avevamo sentito parlare. Cosa fare allora? Semplice: consultare il catalogo di Biblioteche di Roma e richiederla in prestito!
Parte la ricerca degli “introvabili”: il giovedì, ogni 15 giorni a partire dall'8 ottobre, dalle pagine FB e Instagram della Biblioteca Nelson Mandela proponiamo dai nostri scaffali un classico da tempo non ripubblicato ma che assolutamente merita di essere letto (o riletto), perché, per tornare a Calvino, sarà sicuramente «un libro che non ha mai finito di dire ciò che ha da dire».Sindiwe Magona, Questo è il mio corpo!
«È un libro che avevo paura a scrivere, ma sono triste e arrabbiata quanto basta per farlo». Effettivamente, questo classico della letteratura sudafricana non esita minimamente a criticare, smontandole, le strutture sociali, patriarcali, maschiliste e sessiste delle comunità nere di Cape Town e non solo. Protagoniste sono cinque amiche (le FFF, Five Firm Friends) le quali, dopo la morte per Aids di una di loro, Beauty, decideranno di riequilibrare i rapporti con i rispettivi partner iniziando un percorso di consapevolezza che le porterà a contestare le abitudini sessuali che questi violentemente impongono loro, rivendicando ciascuna che Questo è il mio corpo!, ovvero il diritto a non contagiarsi di una malattia che in quegli anni, in Sudafrica, colpiva le donne quattro volte più degli uomini. L’Aids, all’uscita del romanzo, era tanto diffuso quanto impronunciabile, al punto che il signor Mtini è costretto dal genero e dal resto della famiglia ad accettare la versione ufficiale per cui la figlia Beauty era malata di tubercolosi, al fine di evitare un’accusa di promiscuità sessuale che, comunque, sarebbe ricaduta su di lei e non sul marito, adultero come tanti (troppi!). Magona affronta, coraggiosamente, un problema atavico: la supremazia culturale dell’uomo sulla donna, causa (oltre alle politiche contingenti del governo e della Chiesa) della pandemia che ancora oggi sta decimando le comunità nere sudafricane, e invita la donna, alla quale Dio «donò una pelle «resistente come Madre Terra», a divenire modello di ricerca di una nuova umanità.
Sindiwe Magona, Questo è il mio corpo!, Edizioni Gorée, 2007
https://www.bibliotechediroma.it/opac/resource/questo-e-il-mio-corpo/RMB0314364
Jorge Amado, La doppia morte di Quincas l’acquaiolo, Einaudi, 2005
https://www.bibliotechediroma.it/opac/resource/la-doppia-morte-di-quincas-lacquaiolo/RMB0252989
Margaret Atwood, La donna da mangiare
È lei a dover togliere le bandierine dalla grande mappa dei dipendenti appesa in ufficio quando qualcuno viene licenziato, per una gravidanza, «atto di slealtà nei confronti dell’azienda», o anche solo per una gamba rotta. E le colleghe? Beh, tutte e tre bionde artificiali: «Dopo aver viaggiato abbastanza vorrebbero sposarsi e sistemarsi». Le sue due amiche? O donna emancipata, l’una, o tutta moglie e madre, l’altra. Con Peter, il suo fidanzato? Mah, la «prassi» e lo «schema» sono sempre quelli: «Come è andata? Mi chiese con indifferenza, la bocca contro la mia spalla. Me lo chiedeva sempre». E Marian in tutto questo? Quel che sappiamo è che una sera «Abbassò gli occhi sulla bistecca mangiata a metà e improvvisamente la vide come un pezzo di muscolo». Il primo romanzo di Margaret Atwood, siamo nel 1969, è così che inizia: «Sono certa che stavo bene venerdì, quando mi alzai», dopodiché si finisce, attraverso gli occhi della protagonista, dentro la società moderna, di ieri e di oggi.
Margaret Atwood, La donna da mangiare, Guanda, 2003
https://www.bibliotechediroma.it/opac/resource/la-donna-da-mangiare/RMB0210866
La vita del poeta argentino Evaristo Carriego, noto anche per un tango di Eduardo Rovira a lui intitolato, cantore dei bassifondi, in quanto la povertà «implica un più immediato possesso della realtà», costituisce senza dubbio una via di accesso privilegiata al mondo letterario e non solo di Jorge Luis Borges. È negli «angoli di aggressione o di solitudine», dove «uomini furtivi» abili con il coltello «si chiamano con un fischio e si disperdono di colpo nella notte», che l’autore argentino appena trentenne (è del 1930 l’edizione originale), fa rivivere il poeta con l’intenzione esplicita di ricercare quelle immagini «che vivono nel fondo di ogni coscienza argentina». È insieme a Carriego, scomparso quando Borges aveva tredici anni - «Non mancava mai la domenica a casa nostra, di ritorno dall’ippodromo» - che il lettore viene condotto in un viaggio attraverso i luoghi, i costumi, le abitudini dell’infanzia del grande scrittore argentino. Tutto ciò per un motivo molto semplice: «Perché Buenos Aires è profonda, e mai, nel disinganno o nella pena, mi sono abbandonato alle sue strade senza riceverne un insperato conforto, ora nell’avvertire l’irrealtà, ora nelle chitarre dal fondo di un patio, ora nello sfiorare altre vite».
Jorge Luis Borges, Evaristo Carriego, Einaudi, 1972
https://www.bibliotechediroma.it/opac/resource/evaristo-carriego/RMB0197702
Il brano musicale A Evaristo Carriego è in Tangobar, operita milonguera:
È attraverso oggetti di uso comune - per finire poi alle persone - che Heinrich Böll indirizza la sua sottile critica alla società del benessere e alle sue illusioni. Comincia con una bilancia: nessuno deve averne una in casa, questa la legge che la famiglia Balek ha imposto ai contadini del villaggio; forse una questione di giustizia? Prosegue con una vecchia tazza da caffè che racconta la sua storia e quella di chi l’ha posseduta: pensate, si è sposata ben due volte … la tazza! E i portacenere Schrörschnauz che hanno vinto il primo premio al concorso per i migliori portacenere? Il dott. Murke «non aveva ancora avuto il coraggio di sporcarli con la cenere della sigaretta o addirittura con qualcosa di più antiestetico ancora, come una cicca». E se la penna con il tappo mangiucchiato conservata al museo non fosse appartenuta a quel famoso poeta? Insomma: si ride solo per lavoro; si fanno pagare le tasse ai cani; si nascondono elefanti in cantina, e c’è chi pensa che sia sempre la vigilia di Natale! E non manca l’analisi socio-economica: ve la ricordate la stazione? Cosa diceva il giovane Goswin? Ah sì: «Vedrete voi, voi lo vedrete». Ci sta ingannando Böll? O ci sta parlando di noi? Non resta che leggerli, questi brevi racconti.
Heinrich Böll, Racconti umoristici e satirici, Bompiani, 1990
https://www.bibliotechediroma.it/opac/resource/racconti-umoristici-e-satirici/RMB0027903
Alba de Céspedes, Invito a pranzo
Il volume vanta l'originale e pittoresca traduzione di un altro romanziere, il napoletano Attilio Veraldi (1925-1999), autore di noir e gialli dalle atmosfere tarantiniane ante litteram. E non a caso Taxi Driver è uno dei film prediletti dal regista pulp statunitense, e qui il cerchio si chiude.
Richard Elman, Taxi Driver, Sonzogno, 1976
link: https://www.bibliotechediroma.it/…/re…/taxidriver/RMB0000824
Gianna Manzini, La Sparviera
Vincitore, nel 1956, del Premio Viareggio, a pari merito con Le parole sono pietre di Carlo Levi, questo romanzo consentì a Gianna Manzini di ottenere, a sessant’anni, il riconoscimento più importante della sua carriera. La Sparviera. Già, ma cos’è? È presente sin dall’inizio nei dialoghi dei due protagonisti, Giovanni e Stella, ancora bambini: «Allora non è vero che l’hai vista». «Era spogliata o vestita?». «Sarebbe stato bello farci amicizia», insiste lei. «Era in tanti modi. Cambiava», risponde lui, imbarazzato sin da allora davanti al viso e alla spigliatezza della bambina. «Cambiava». Mai risposta fu più drammaticamente esatta. Cambia, scompare, ricompare quando meno ce lo aspettiamo, La Sparviera è lì a ricordarci che non abbiamo il pieno controllo delle nostre vite, che programmarle razionalmente ha senso fino a un certo punto, e che non ci sono rimedi che possono colmare il vuoto lasciato dalle passioni incompiute. La Sparviera è «l’immagine di un senso rapinoso della vita. Una tempesta che unisce e divide per sempre, il segno di un destino che chiama, che vuole, che esige», come la definì Eugenio Montale. Ed è la storia di una grande passione: «Sorrideva, continuava a sorridere, senz’avanzare. E nel suo sorriso c’era qualcosa di monellesco, e qualcosa d’estremamente consapevole. Si riprendeva dal fondo dei sogni di lui; e di quei sogni faceva la propria realtà».
Gianna Manzini, La Sparviera, Libreria dell’Orso, 2005
Link: https://www.bibliotechediroma.it/opac/resource/la-sparviera/RMB0285472
Link al saggio Invito alla lettura di Gianna Manzini, di Enzo Panareo, Mursia, 1977 (la frase di Eugenio Montale è citata a p. 68):
https://www.bibliotechediroma.it/opac/resource/invito-alla-lettura-di-gianna-manzini/RMB0199790
Charles Williams, Finalmente domenica!
Quando François Truffaut scorse la sua musa Fanny Ardant con un trench da detective, decise che doveva per forza girare un film ad hoc per farglielo indossare.
Per il soggetto, il regista si ispirò a un romanzo hard boiled americano, The Long Saturday Night (1962) di Charles Williams.
L'autore, nato a San Angelo nel 1909 e morto a Los Angeles nel 1975, è uno dei migliori romanzieri degli anni '50–'60 che unisce la suspence di Cornell Woolrich alle atmosfere torbide di James M. Cain, ma proprio questo romanzo balza agli occhi di Truffaut perché, stranamente per l'epoca, a indagare è una donna.
Finalmente domenica! è infatti la storia di Warren (nel film intepretato da Trintignant), un agente immobiliare accusato di aver ucciso l'amante della moglie, conturbante e bugiarda. L'unica a credere nell'innocenza dello sventurato è Barbara Ryan, la segretaria, «una ragazza che sa dove è sepolta ogni cosa, cadaveri inclusi», una «divorziata di trent'anni» con «capelli rosso mogano che sembrano perennemente arruffati, una bocca generosa in un viso altrimenti sottile, occhi di un azzurro fresco e limpido, nonché un'aria di bonario cinismo, come se fosse ancora affezionata al genere umano pur non aspettandosi grandi cose da esso.»
Chi ha visto il film non può non riconoscere la Ardant in questa descrizione: la pellicola non è ambientata a New Orleans come il libro, bensì in un paese a sud della Francia, eppure il regista ha colto lo spirito del romanzo, reinterpretandolo con la sensibilità e l'ironia tutta europea dei maestri della nouvelle vague.
Se il film di Truffaut ha la leggerezza e lo stile della commedia noir francese, il romanzo sa di whisky e di polvere da sparo come i migliori crime della narrativa americana, ed entrambi vale la pena riscoprirli.
Charles Williams, Finalmente domenica!, I Classici del Giallo, 1983 (I edizione Longanesi, 1962)
Link: https://www.bibliotechediroma.it/…/query/finalmente+domenica
Vincenzo Cerami, Ragazzo di vetro
Un albergo in montagna. D’estate, Stefano, adolescente, sta trascorrendo una delle sue ultime vacanze insieme ai genitori. C’è Lucia, la giovane cameriera. Sandro, l’amico di sempre che sta passando l’estate a Londra. C’è la massa degli ospiti della pensione, quella che «esprime solo volgarità e mediocrità», che è «fatta di persone lerce, senza faccia». C’è la signora Helga, la proprietaria dell’albergo, persona avida e meschina, che tale massa governa. Stefano rifiuta tutto ciò, cerca altro, vorrebbe andarsene, vorrebbe gettare all’aria quelle maschere di mediocrità, gridare la propria vita e liberarla all’insegna di rapporti più umani che consentano alla sua individualità di esprimersi. C’è un uomo, anziano, che ricorda tanto il signor Aschenbach, protagonista de La morte a Venezia, romanzo che il professore di lettere ha consigliato a Stefano di leggere. Stefano e Aschenbach hanno qualcosa in comune: tutti e due avvertono «nel fondo della coscienza uno sfibramento allarmante, con tanto imprecisato desiderio di cose nuove e lontane».
Vincenzo Cerami, Ragazzo di vetro, Garzanti, 1983
Link a Ragazzo di vetro
Link a La morte a Venezia
Olive Schreiner, Preludio
Olive Schreiner nasce nel 1855 nella Colonia del Capo. È la prima scrittrice di origine sudafricana, di lingua inglese, ad ottenere fama internazionale, non solo come narratrice ma anche come saggista, proponendo una riflessione sui diritti delle popolazioni native africane e sui diritti della donna destinata ad influenzare la futura elaborazione di questi temi. Olive Schreiner divenne famosa per il romanzo Storia di una fattoria africana (The Story of an African Farm), ma lavorò fino al 1920, anno della morte, ad un romanzo dal titolo From Man to Man che rimase incompiuto e fu pubblicato postumo dal marito (1926). La lettura del Preludio a questo secondo romanzo –l’unica parte che Olive Schreiner riteneva compiuta– costituisce una via di accesso privilegiata al mondo letterario di questa importante autrice, che proprio narrando la giornata della piccola Rebekah ritorna sulle origini della sua vocazione di narratrice e della sua indole ribelle alle convenzioni sociali che la relegavano sin da bambina ad assumere ruoli e comportamenti predefiniti. «Tra l’erba alla sinistra del pero c’era uno strano sentiero che non portava da nessuna parte: era lungo solo qualche metro, ma sembrava molto frequentato perché a furia di essere calpestato il fondo era tutto liscio. Era stata lei a tracciarlo: lo percorreva sempre avanti e indietro quando inventava le sue storie». Un’ottima lettura verso l’8 marzo.
Olive Schreiner, Preludio, Empirìa, 1987
https://www.bibliotechediroma.it/opac/resource/preludio/RMB0004274
Speciale 8 marzo: Louisa May Alcott, L'eredità
L'Eredità narra le disavventure di Edith Adelon, giovane orfana di origini italiane accolta presso la nobile famiglia degli Hamilton, e della lunga estate che metterà alla prova la sua paura e insieme il suo desiderio di amare e di essere amata.
Leggere il romanzo è come entrare nella mente di una Alcott adolescente, innamorata delle storie gotiche e dei feuilleton, ma soprattutto della scrittura, e tra quelle righe appassionate si intravede il suo futuro di romanziera.
Chi ha amato Piccole donne troverà in Edith la stessa purezza e la stessa resilienza al dolore con cui Jo va alla ricerca del suo posto nel mondo.
Come in tutti i giovani, lo sguardo dell'autrice qui è più assoluto e meno nostalgico: Bene e Male sono poco sfumati, così come la psicologia dei personaggi, ma la scrittura è affascinante, e la storia che la Alcott ragazzina riesce a concertare ci tiene con il fiato sospeso fino alla fine.
Il volume è stato pubblicato in Italia da un'interessante casa editrice perugina, la “Jo March”, specializzata in romanzi inediti di scrittrici dell'Ottocento: è un testo introvabile e fa parte dei piccoli tesori della nostra biblioteca.
Louisa May Alcott, L'eredità – The Inheritance, Jo March, 2015
https://www.bibliotechediroma.it/opac/query?query=eredit%C3%A0+alcott
Richard Wright, Paura
Siamo nella Chicago degli anni ‘30. Nel ghetto di South Side. In una stanza infestata dai ratti. Nella testa di un giovane afroamericano di nome Bigger Thomas, il quale desiderava solo una cosa: «vedersi concedere una possibilità di vivere come gli altri, anche se era nero». A questo, Bigger, non era disposto a rinunciare. È osservando la realtà attraverso gli occhi del protagonista, che Richard Wright ci spinge a seguire il ritmo di «indifferenza e violenza», di «astratte ruminazioni» e di «intenso desiderio», di «silenzio» e di «furore» che contraddistingue la vicenda di questo ragazzo.
Bigger si era sempre limitato a rubare agli afroamericani. Era più sicuro derubare gente del suo «colore»: i poliziotti bianchi, infatti, non facevano mai indagini approfondite «per trovare dei negri che avessero commesso reati contro altri negri». Ora ha l’opportunità di scatenare contro i bianchi il proprio odio, quell’odio derivante dalla “Paura” che essi stessi gli hanno instillato. Se da un lato i crimini che Bigger commetterà da questo momento in poi sono assolutamente condannabili, la domanda che Wright poneva e pone tutt’ora al lettore americano e occidentale è cruciale: dove inizia il libero arbitrio e dove finiscono i condizionamenti sociali? «Quando – Richard Wright – parla ai bianchi […] è per comprometterli, costringerli a valutare le loro responsabilità, suscitare in loro indignazione e vergogna», scriveva Jean Paul Sartre.
Il romanzo fu pubblicato in America nel 1940 e divenne subito un best seller. In Italia l’ultima edizione Tascabili Bompiani risale a quasi quarant’anni fa, nonostante la sua incontestabile attualità: come sostenne il padre dell’esistenzialismo francese i libri di Richard Wright rimarranno «vivi» finché il problema degli afroamericani «non sarà risolto». È per questo motivo che ve lo proponiamo, anche se preferiremmo che non fosse più attuale.
Richard Wright, Paura, Bompiani, 1983
https://www.bibliotechediroma.it/opac/resource/paura/RMB0000978
Le citazioni di Jean Paul Sartre sono tratte da Che cos’è la letteratura? Lo scrittore e i suoi lettori secondo il padre dell’esistenzialismo, Il Saggiatore, Milano, 2009, pp. 60 e 112.
Link Bibliotu al saggio: https://www.bibliotechediroma.it/opac/resource/che-cose-la-letteratura-lo-scrittore-e-i-suoi-lettori-secondo-il-padre-dellesistenzialismo/RMB0629403
Tiziano Sclavi, Dellamorte Dellamore
«[...]La Morte rognosa, la Morte lasciva,
la Morte che dona, la Morte che prende,
la Morte che ruba, la Morte che rende,
[…] la Morte che vive, la vita che muore.
La Morte! La Morte! La Morte e l’Amore!»
Non tutti sanno che Tiziano Sclavi, nel creare Dylan Dog, si ispirò a Francesco Dellamorte, il protagonista del suo romanzo Dellamorte Dellamore. L'autore, nato nel 1953 a Broni (PV) e collaboratore di diverse testate tra cui il Corriere dei Ragazzi e il Corriere dei Piccoli, scrive nel 1983 la storia di Buffalora, uno sperduto paesino lombardo, in cui, a causa di una misteriosa epidemia, i morti risorgono. A far fronte alla situazione tocca a Francesco Dellamorte, il custode del cimitero, che di giorno seppellisce i cari estinti, e di notte, quando escono dalle tombe, li fa fuori sparandogli alla testa, insieme al muto e bizzarro aiutante, Gnaghi. Il romanzo, onirico e rarefatto, a metà tra il surrealismo di Buzzati e il sarcasmo di Bierce, narra di una dimensione in cui l'unico amore possibile è quello tra i vivi e i morti: Dellamorte si innamora infatti di una ritornante, con tutte le conseguenze del caso. Nel 1986 Sclavi darà i natali all'indagatore dell'incubo, trasformando il becchino lombardo in un detective londinese e dotandolo di una spalla fin troppo parlante, quale Groucho Marx. Dellamorte, dedito al fumo, al bere e al sesso mercenario, lo si potrebbe definire un Dylan Dog che ha perso l'innocenza. I due personaggi sono uno il lato oscuro dell'altro, ma riflettono lo stesso pessimismo di fondo, e un'acuta critica nei confronti del bigottismo di provincia. Nel cupo e poetico lungometraggio di Michele Soavi (1994), il cinico scavafosse di Buffalora sarà interpetato da Rupert Everett, le cui fattezze avevano già ispirato quelle di Dylan, sovrapponendo ancora una volta l'identità e il destino dei due personaggi.
Tiziano Sclavi, Dellamorte Dellamore, BUR, rist. 1995
romanzo: link
film: link
Bibliografia Tiziano Sclavi: link
Fare un tuffo nella biografia giovanile di Twain significa anche immergersi nella «giovinezza» degli Stati Uniti d’America. Ed è guardando il fiume, fuori e dentro il battello – poderi in rovina, baracche di legno, piantagioni di zucchero, “campeggi acquatici”, e trafficanti, giocatori d’azzardo, cercatori di fortuna – che il lettore ha la possibilità di conoscere l’America non solo prima della guerra civile, ma anche dopo, periodo al quale è dedicata la seconda parte del libro, quando l’illuminazione e le ferrovie avevano fortemente mutato la vita degli abitanti del fiume.
Vita sul Mississippi, inoltre, può essere considerato un modello (non sappiamo se il capostipite) di quella narrativa dei fiumi (due esempi tra i tanti Danubio di Claudio Magris e Tevere controcorrente di Marzio G. Mian), che vede nel fiume il luogo della stratificazione storica, della contaminazione e dello scambio culturale.
Del resto: «Le scorciatoie scompigliano confini e giurisdizioni. Esempio: un uomo risiede oggi nello Stato del Mississippi. In nottata viene la scorciatoia, e domani quell’uomo, con la sua proprietà, si trova sull’altra riva del fiume, entro i confini e sotto le leggi dello Stato della Louisiana! Questa cosa se fosse accaduta in passato lungo il corso superiore del Mississippi avrebbe potuto trasferire uno schiavo dal Missouri all’Illinois e far di lui un uomo libero».
Mark Twain, Vita sul Mississippi, Opere Nuove, 1962: link
Claudio Magris, Danubio, Garzanti, 2015: link
Marzio G. Mian, Tevere controcorrente, Neri Pozza, 2019: link
Sito di The River Journal Project, progetto giornalistico multimediale che riporta temi di attualità esplorando i più grandi fiumi del mondo (di cui fa parte Marzio G. Mian): www.riverjournal.it
Jean-Paul Sartre, Il rinvio
Non è della guerra che Jean-Paul Sartre ci parla ne Il rinvio, secondo libro della trilogia dal titolo Le vie della libertà (lo farà nel terzo ed ultimo volume La morte nell’anima), non è di vicende private, giovanili, (l’ha fatto nel primo, L’età della ragione), bensì tema centrale del romanzo è l’attesa della guerra. Il nuovo conflitto mondiale incombe sulla generazione di Mathieu e della sua cerchia di amici, riducendo le loro coscienze individuali ad un’unica grande coscienza collettiva colma di angoscia per un conflitto che di rinvio in rinvio diviene sempre più ineluttabile. Pubblicato nel 1945, e ambientato nel 1938, durante la settimana delle trattative che portarono alla temporanea tregua di Monaco, nel romanzo si dipanano diverse trame attraverso una tecnica della contemporaneità portata all’estremo (per cui siamo a Parigi quando il cameriere inizia a versare da bere nel bicchiere e ci troviamo a Praga quando questo è colmo). Se abbiamo la pazienza di lasciarci trascinare dal flusso della narrazione, pagina dopo pagina l’idea che quella umana sia un’unica grande famiglia e che la guerra riguardi tutti, ovunque ci troviamo e qualunque cosa stiamo facendo, non potrà che divenire parte di noi stessi.
Jean-Paul Sartre, Il rinvio, Arnoldo Mondadori, 1977: link
Jean-Paul Sartre, La morte nell’anima, Arnoldo Mondadori, 1971: link
Jean-Paul Sartre, L’età della ragione, Bompiani, 2001: link
Erskine P. Caldwell, La via del tabacco
Accade che tra gli scaffali delle biblioteche si possano scovare perle rare, e La verità sul caso Smith è una di queste. Sfogliare le pagine ingiallite di questo volume, oggi introvabile, è come compiere un vero e proprio viaggio nel tempo. Tra i 32 racconti pubblicati giganteggiano nomi come Truman Capote, Jack Kerouac, Saul Bellow, ma la magia è che se ne parla al presente, come scoperte contemporanee, ancora prive di quella rarefatta reverenza che si attribuisce ai classici. La raccolta è uscita nel 1963, e accanto agli autori citati spiccano racconti allora inediti da noi tra cui Un brav'uomo non s'incontra tutti i giorni di Flannery O' Connor (che dalla bio viveva allora con i genitori cattolici nella fattoria di famiglia!), e l'inquietante La lotteria di Shirley Jackson. Entrambe le autrici, oggi di culto, erano allora sconosciute in Italia, dimostrazione che i curatori ci vedevano lungo,e non a caso si parla di Fruttero & Lucentini. Il duo, celebre per aver rinnovato il giallo italiano con La donna della domenica (1972) ha diretto dal 1964 al 1985 la rivista Urania, pubblicando autori di spessore per il fantastico. La verità sul caso Smith raccoglie invece storie che hanno come protagonista l'Uomo Medio Americano, il “signor Smith” appunto, lontano dai grandi eroismi alla Hemingway e Mark Twain. Tra le chicche dell'antologia, il racconto La ragazza messicana a cui Kerouac si ispirò per scrivere Sulla strada.
Carlo Fruttero, Franco Lucentini (a cura di), La verità sul caso Smith – Antologia della nuova narrativa americana, Mondadori, 1963: link