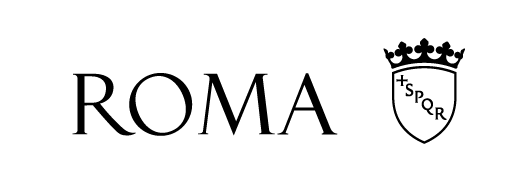sabato
31
ottobre
mercoledì
24
giugno
sabato
31
ottobre
BILLonline - L'uomo invisibile
Il Maggio dei Libri
L'uomo invisibile H.G. Wells, L’uomo invisibile, Fanucci, 2017
Il romanzo è ambientato nel XIX secolo, nei sobborghi di Londra e del Sussex. Il protagonista è Griffin, un fisico molto abile, le cui capacità sono però del tutto ignorate dai suoi conterranei. Matura per questo il grande desiderio di realizzare una scoperta sensazionale, che lo renda ricco e gli permetta di conquistare il rispetto e la stima dei suoi conoscenti. Griffin, con molto impegno, riesce a sviluppare un procedimento che permette di rendere invisibile qualsiasi oggetto. Dopo averne testata l’efficacia, ripete l’esperimento su un gatto e poi su sé stesso. Il tentativo su di lui riesce perfettamente, ma ben presto scopre che essere invisibile implica una serie di conseguenze negative a cui non avrebbe mai pensato.
La scelta di inserire questo classico nella BILL segue gli obiettivi propri dell’intero progetto Biblioteca della Legalità: l’accettazione dell’altro e della diversità, ma prima di tutto di se stessi, l’emarginazione provocata e autoindotta, l’isolamento ma soprattutto l’autoisolamento e, facendo un salto nella nostra epoca, la necessaria lotta a fenomeni quali bullismo/cyberbullismo e la pratica dell’inclusione come elemento fondante di una società.
Infatti le tematiche trattate nel libro ci danno un vantaggio nel riproporre ai ragazzi problemi e soluzioni di grande attualità.
La prima parte del libro è più complessa non svelando nell’immediato il motivo scatenante per cui Griffin diventa trasparente. Spingendosi fino a metà della storia, attraverso spezzoni di ricordi, il lettore riesce a comprendere cosa sia realmente accaduto al geniale scienziato. Con lo scorrere delle pagine, l'autore porta alla luce la rabbia e il dolore che hanno spinto lo stesso protagonista a rendersi invisibile. Il senso di inadeguatezza entra a far parte della sua vita quando si ritrova nelle vesti di genio incompreso, non apprezzato dall’ambiente professionale che non prende minimamente in considerazione i suoi esperimenti e tantomeno i risultati delle sue ricerche. Sono questi elementi la causa scatenante della sua invisibilità che otterrà grazie ad una scoperta estrema che mette a repentaglio la sua vita.
Se catapultiamo la storia di Griffin nella nostra contemporaneità, capiamo quanto l’autore non voglia raccontare una storia avventurosa ma piuttosto spingerci verso una riflessione più profonda: perché diventare invisibili?
La nostra vita, fin dall’infanzia, si muove su binari su cui scorrono le nostre azioni, da una parte, e la ricerca di approvazione, dall’altra da parte di: familiari, compagni di classe e di gioco, colleghi, amici, congiunti, figli e di molte altre persone che incontreremo nel nostro percorso. Quante volte ci siamo sentiti inadeguati non riuscendo ad ottenere l’ambita approvazione? Quante volte abbiamo dovuto combattere sentendoci emarginati o abbiamo gettato la spugna non avendo risorse per sentirci adeguati? Quante volte sono le nostre paure a condurci all’isolamento?
Risponde Wells riversando nel libro la sua parte personale più intima e trasferendo sulle pagine quanto lui stesso aveva potuto sperimentare: la sensazione di inadeguatezza perenne che lo costringeva a rincorrere stima e approvazione, persino quando la fama lo aveva già raggiunto, e a temere il fallimento e la caduta davanti al mondo esterno.
PREFAZIONE
La prefazione nell’edizione Fanucci 2017 è curata da Carlo Pagetti. Fornisce le coordinate culturali, storiche e interpretative del testo, rilevandone gli aspetti che lo accomunano ad altre opere ad esso contemporanee. Di seguito un esemplificativo estratto:
“L'organizzazione narrativa de L'uomo invisibile segna un sostanziale cambiamento rispetto all'approccio diretto, che, ne La macchina del tempo e ne L'isola del dottor Moreau, si basava sull'uso quasi esclusivo di un io narrante, un osservatore non certo distaccato del viaggio di esplorazione nel tempo futuro o su un'isola del Pacifico. Ne L'uomo invisibile, invece, prevale la narrazione asettica, e a tratti ironica, di una voce narrante che cerca di dare oggettività al racconto, e semmai privilegia le reazioni della comunità, che tenta di difendersi dall'aggressione di Griffin – questo è il nome, tratto dal segno araldico del grifone, dell'Uomo Invisibile – la cui voce finisce per dissolversi, fino a che il protagonista diventa, come osserva Frank McConnel (1981), - invisibile anche nei termini della stessa tecnioca narrativa -. È pur vero che la seconda parte de L'uomo invisibile consente al protagonista di esprimere la sua testimonianza diretta riguardo alle ricerche di laboratorio, che hanno praticamente cancellato il suo corpo come entità fisica percepibile, e questo avviene con un pathos che richiama le sofferenze non tanto dello scienziato faustiano Frankenstein, quanto del mostro, la sua creatura sola e abbandonata dopo la nascita, la cui dolente testimonianza rappresenta il nucleo centrale del romanzo di Mary Shelley. Come la creatura mostruosa, anche Griffin esplode in una furia omicida, in modo che gli esseri umaniin cui si imbatte, e che lo ignorano, possano vederlo. […] Al di là dei cospicui echi intertestuali, teatrali e letterari, L'uomo invisibile è certamente una parabola sulla tragedia della diversità, che è sempre grottesca e ripugnante agli occhi di chi non vede perché non vuole vedere, e ha paura di riconoscersi in essa; ma il romance wellsiano propone anche un discorso ironico e beffardo sul carattere illusorio dell'esperienza, anche di quella scientifica. Con la sua esistenza Griffin il Grifone mette a dura prova quelle categorie razionali che il potere scientifico dovrebbe aver consolidato. Il terrore che si sprigiona dall'uomo senza volto – senza bocca per parlare, senza orecchie per ascoltare (eppure parla e ascolta) – non comporta solo il pericolo di mettere a nudo il proprio vuoto interiore, è anche un'anomalia della materia solida, una forma indistinta e quasi impalpabile che rappresenta la sostanza capricciosa di ogni creazione fantastica.”
INCIPIT E ALTRI BRANI SIGNIFICATIVI
Estratti dall’edizione H.G. Wells, L’uomo invisibile e altri racconti, Club degli Editori, Milano.
Nella parte seguente il carattere sinistro del protagonista emerge in modo ancor più chiaro, nella descrizione delle sue abitudini, dei suoi accessi d’ira e della sua misantropia:
“Il forestiero non andava in chiesa e per lui non c’era davvero nessuna differenza fra la domenica e i giorni lavorativi, anche per quanto riguardava gli abiti. Lavorava, come pensava la signora Hall, in modo molto irregolare. Qualche volta si alzava presto ed era continuamente occupato. Altri giorni si alzava tardi, camminava per la stanza, brontolava adirato per ore intere, fumava e dormiva nella poltrona vicino al camino. Non aveva rapporti con il mondo fuori del villaggio. Il suo umore era sempre molto incostante: si comportava quasi sempre come uno che subisca continui e intollerabili soprusi e, una volta o due, sbatté via, lacerò, schiacciò o ruppe, in terribili accessi di violenza, tutto ciò che aveva intorno. Mantenne sempre l’abitudine di parlare da solo a bassa voce e la signora Hall, nonostante ascoltasse sempre coscienziosamente, non riuscì mai a capire il senso di ciò che udiva. Usciva raramente di giorno ma al crepuscolo andava fuori imbacuccato in modo inverosimile, sia che facesse caldo sia che facesse freddo, e sceglieva i sentieri più solitari e più ombreggiati da alberi o da muri. Quei suoi grandi occhiali e la faccia spettrale tutta bendata, sotto la gran falda del cappello, sbucarono una volta, all’improvviso e producendo un’impressione piuttosto sgradevole, davanti a due operai che tornavano a casa. Una sera, alle nove e mezzo, Teddy Henfrey [l’orologiaio della cittadina] precipitandosi fuori di Scarlet Coat, si prese un grande spavento vedendo quella testa simile a un teschio – il forestiero camminava con il cappello in mano – illuminata dalla luce improvvisa che usciva dalla porta aperta della taverna. Alcuni bambini che lo videro al calar della notte si sognarono di spettri: non si sa se egli detestasse i bambini più di quanto essi detestavano lui, o viceversa. Di certo, comunque, c’era un odio piuttosto forte da entrambe le parti.”
Nel seguente passo il protagonista svela al suo compagno i particolari dell’esperimento che lo avevano portato a divenire invisibile e le terribili sofferenze che aveva dovuto subire:
“Però un’idea era chiara in me: dovevo portare a termine le mie ricerche. Era un’idea fissa che mi dominava ancora. E dovevo finire presto, perché il denaro era quasi terminato. Guardai, intorno a me la collina piena di bambini che giocavano e di ragazze che li sorvegliavano; cercai di pensare a tutti gli innumerevoli vantaggi che poteva avere un uomo invisibile. Dopo un po’ mi trascinai a casa, presi del cibo e una forte dose di stricnina e mi misi a dormire vestito, sul letto disfatto. […]
- Fra quel pomeriggio e la notte seguente feci tutto. Mentre ero ancora sotto la dolorosa e debilitante influenza delle droghe per scolorire il sangue, qualcuno bussò ripetutamente alla porta. […] Ma tutto era orribile; non mi aspettavo una sofferenza del genere. Una notte di angoscia tormentosa, di sofferenze insopportabili e di continui svenimenti. Strinsi i denti e, anche se mi sentivo la pelle e il corpo in fiamme, rimasi teso come in coma. Allora compresi perché il gatto avesse miagolato tanto fino a che non gli avevo dato il cloroformio.”
TRASPOSIZIONI CINEMATOGRAFICHE
La filmografia ispirata a questo libro è particolarmente abbondante. La prima realizzazione cinematografica risale al 1933. Si tratta della pellicola dal titolo L’uomo invisibile ( The invisible man), diretto dal regista James Whale ed interpretato da Claude Rains. A questo primo film si sono ispirati molti altri:
- Il ritorno dell’uomo invisibile, del 1940, regia di Joe May
- La donna invisibile, del 1940, regia di A. E. Sutherland
- La rivincita dell’uomo invisibile, del 1940, regia di F. Beebe
- Gianni e Pinotto contro l’uomo invisibile, del 1951, regia di C. Lamont, che costituisce una parodia delle precedenti rappresentazioni
- La vendetta dell’uomo invisibile, del 1963, regia di R. Nussbaum
- L’inafferrabile, invincibile mr. Invisibile, del 1973, regia di A. Margheriti
- Avventure di un uomo invisibile, del 1992, regia di J. Carpenter
- L’uomo senza ombra, del 2000, regia di P. Verhoeven
- L’uomo senza ombra 2, del 2006, regia di C. Fah, seguito del precedente film
- L’uomo invisibile, del 2020, regia di L. Whannell. Il film è andato in onda nelle sale cinematografiche statunitensi il 28 febbraio 2020. In Italia, in cui la pubblicazione era prevista per il 5 marzo ed è stata rinviata a causa della pandemia di Coronavirus, è stato distribuito in video on demand il 27 marzo 2020. In questo recente adattamento è il ricco ingegnere Adrian Griffin ad impersonare l’uomo invisibile. Per anni riesce a tenere sottomessa Cecilia Kass, che ha una relazione violenta con lui, ma poi riuscirà a fuggire ed infine ad ucciderlo.
Inoltre su questo libro sono state realizzate anche diverse serie televisive, adattate o liberamente ispirate all’originale, quasi tutte prodotte da emittenti statunitensi e britanniche, ad eccezione di una serie animata coprodotta da Rai Fiction.
CURIOSITÀ
Il testo è stato pubblicato in molte edizioni, per lo più da case editrici anglo-americane e italiane. La prima pubblicazione in lingua inglese risale al 1897. In Italia fu tradotto poco dopo e pubblicato per la prima volta nel 1900. Di seguito le immagini di copertina più significative:







#IlMaggiodeiLibriBiblioCollinadellaPace
#BILLonlineBibliotecaCollinadellaPace
24/06/2020 Pao.Tin